
L’alba. Una smorta prima ora luceva. Tra le sterrate fangose si camminava ogni notte a sentire i ciuffi del riso che a moltitudini strusciavano sui polpacci il virgulto. La fredda aria della sera, svanita da una settimana, era il ricordo dell’inverno. Le mani di mio padre tenevano le mie sul sentiero giacché di luci solo le stelle erano e, non distante, il Panaro lento andava per l’Emilia.
La second’ora del mattino avanzava con malinconiche sfumature vermiglie che accennavano una quercia, una rondine, un nebbioso marzo ancora acerbo. Me seduto su un troncone spezzato poggiato all’erba. Mi sedeva lì il padre mio, sempre. Era rifugio d’allodole riparato dai venti poiché rimaneva al lato estremo del podere, contro una stacciata di legni usati per bruciare nei camini ed anche perché non mi potevo spostare poi di molto mentr’egli sbarbava il trifoglio per le vacche. Quello mattutino era il momento migliore per tagliare l’erba. Usava una falce con manico di legno e una grossa mezzaluna terminale affilata, lunga all’incirca un metro.
L’acqua torbida a Campolongo in ottobre cresceva con le piene e non poche volte ci obbligava a ritrarci annegando i campi da coltivare. Il Panaro lo sentivi nei muggiti dalle stalle che salivano lamentosi e tutti a pregare, tra le biade ed i vitelli, che piovesse meno e che gelasse sui tetti e sulla terra. L’acqua si malediceva e si adorava come una donna capricciosa che ti promette, come quegli zoccoli duri fatti con le rubinie che ti obbligavano ad abituare i piedi al legno e non ti scaldavano che poco più.
Quarantatré famiglie erano tutto il paese di Pradello, frazione tra Modena e Bologna. Trenta vivevano in un cascinale sopra la collina e tredici avevano preferito casette robuste sparse qua e là. Erano case di contadini con gli anni troppi, rattoppate tra le muffe dei muri e quell’immacolata continuità di pater et filius, uxor et mater e nuove nascite che le stanze grandi contavano un letto unico. Al servizio delle levatrici si copriva di corpi piccoli e mani ancora di più. Accresciute avrebbero poi preteso la terra.
“A so brota e burnitela, an so brota e an so bela, a pas el mare senza nave, a rap el monte senza scala, a so piò brota do te e a vegh a magner a la tevla de re. ”
Mio fratello Giovanni mi affissava smarrito e non capiva che la risposta all’indovinello gli stava proprio sopra la testa. Appiccati al soffitto mazzi di capraggine imbevuti di latte. Sgocciolava, ma poco. Il resto suggeva nelle bocche delle mosche.
Il ronzio crepitava a fuoco le notti. Questo da sempre, anche quando sull’aia mio padre Giacomo tenne per la prima volta in braccio Naigher. Era un cane da pagliaio, un cucciolo con le orecchie pendenti, la coda arricciata ed il pellame macchiato di chiazze scure. Con lui Ruggero che lo aveva portato e regalato. Un cane da pagliaio non valeva nulla ed era uso si desse via alla nascita, più che altro per pietà. Servivano solo ad abbaiare ai foresti ogni qual volta si avvicinavano e per addestrarli, ancora piccoli, si fingeva di farli buttare con rudezza da uno sconosciuto dentro a un forno acceso. Quella mattina scoppiettava e vermigliava ed i guaiti di Naigher, mentre Giacomo lo stringeva verso il fuoco, erano ansanti suppliche adatte ad un mare che sta per infrangere, ad un fiume ostacolato alla foce che scoppia sé stesso perendo sulle radiche e sulle prode.
“At mett in te foran, parche ttan cnossa insun d’intoran. ” Si mescolavano la lingua e l’ululo, la voce scossa e il corpo tremulo, la forza imposta e l’esilità del piccolo, tant’è che, lasciato, come ogni bastardo corse celandosi tra porte da porcile a salivarsi il corpo latrante. La sera mia madre mescolò del pane masticato e qualche pelo nostro e glielo diede in pasto. Sbranò il corpo come i discepoli con Cristo.
Le stagioni si posavano su noi con scorrere da natura, sugli animali, quelli buoni e quelli cattivi. V’erano gesti e usi che ricordavano ad ognuno primavere o inverni tant’è che se fosse lunedì o venerdì, il primo di ottobre o il trenta di aprile, poco importava. La luna, la pioggia, i santi, le formiche, il vento… questi erano i contatori della vita, gli ammonitori di sbagli o riuscite. Il primo di maggio d’ogni anno era uso preparare la majè, una sorta di corona composta da rami di pioppo intrecciato e fiori. Andava posta sui davanzali delle finestre dei locali da proteggere dalle brighe. Le formiche onnipresenti vaganti si arrestavano sui maggiociondoli oppure Giovanni, con mio padre, all’orto benediceva la terra tracciandovi croci cristiane ai lati delle zolle scosse dove poche piante e qualche seme erano il nostro avere. Ai primi tuoni di primavera si pestavano i piedi alle galline affinché producessero uova con la continuità dei canti delle francesine .
Mia madre Elvira mescolava il suo sapere da maestra elementare con quello delle credenze popolari trovandole a tratti utili, a tratti ingenue e per brevi attimi lo stupore, solo questo, le faceva capire che una cosa per stupida che fosse poteva funzionare. Tra Sant’Andrea e Sant’Antonio, una volta l’anno, tutto Pradello uccideva il maiale. Legato per il grugno, vicino all’acqua calda, al paranco e ai coltelli, due uomini lo tenevano stretto. Io me ne stavo distante, ma il suo piangere disperato non potevi non sentirlo. Strappava singhiozzi anche ai neonati che lo confondevano per quello dei fratelli rivolti alle madri ed era senza fine. Si pensava che la lentezza del morire portasse sangue migliore. Il ciabattino era lì pronto a prendersi le setole del porco con le mani, sfregando destra e sinistra. Dal sorriso capivi se erano di qualità. Il parroco e il podestà zagagliavano dei fatti loro che non erano i nostri solo a brevi tratti e già si gustavano con gli occhi le frattaglie perché loro, quelli ricchi, mica ce l’avevano l’nimal. Non si doveva uccidere nel primo quarto di luna e nei giorni del 7, del 13 o del 17. S’era preso dal malocchio, perché magro e malato, gli si tagliava un pezzetto d’orecchio o di coda e, fatto bollire, si gettava poi nel letamaio.
La superstizione era forte tra la povera gente anche in quella istruita. “Che te ne fai del cervello se poi non riesci a pensare per la fame?” diceva mia madre. Ma fuori la fortuna della terra era ancora sufficiente, tra i sorrisi decrepiti dei vecchi e il profumo delle puerpere.
Pradello più che paese era a tratti famiglia, a tratti collina, a tratti piane e pascoli. Qualcuno conosciuto lo trovavi sempre e sempre curvo, o ritto e teso, a sforzarsi di vedere il giorno dopo. Nei giorni del Signore passavano per Pradello strascichi di fiere e mercati grandi con utile ed inutile a fare mostra di sé, con i loro guaritori abilitati, con i loro domatori di pulci. I primi erano di solito settimini, ma andavano bene anche i maschi nati settimi figli della stessa madre o quelli con la camicia. Curavano le vacche e gli uomini con forza d’esperienza che, in alcuni casi, portavano a mo’ di segni sulla pelle propria. Si pagavano quando con un prosciutto, quando con altro. Per gli uomini bastava un favore restituito. Il tempo per farlo era tutta una vita e la garanzia la parola di chi giurava la sua gratitudine. I pazienti stavano con le croci dalla bocca all’ombelico e poi impacchi di portulaca tritata per il verme solitario, pidocchi per l’itterizia. Alla bisogna anche pentolini d’acqua fredda e piombo fuso, sacchetti di spicchi d’aglio da tenere nelle tasche e quant’altro quelli prima di loro avessero sperimentato. Se qualcosa andava male c’era sempre il dottore, ma lontano.
***
Leggiamo e commentiamo insieme questo brano tratto dal libro L’età ingiusta di Giovanni Luigi Navicello, recensito da Nicla Morletti nel Portale Manuale di Mari.

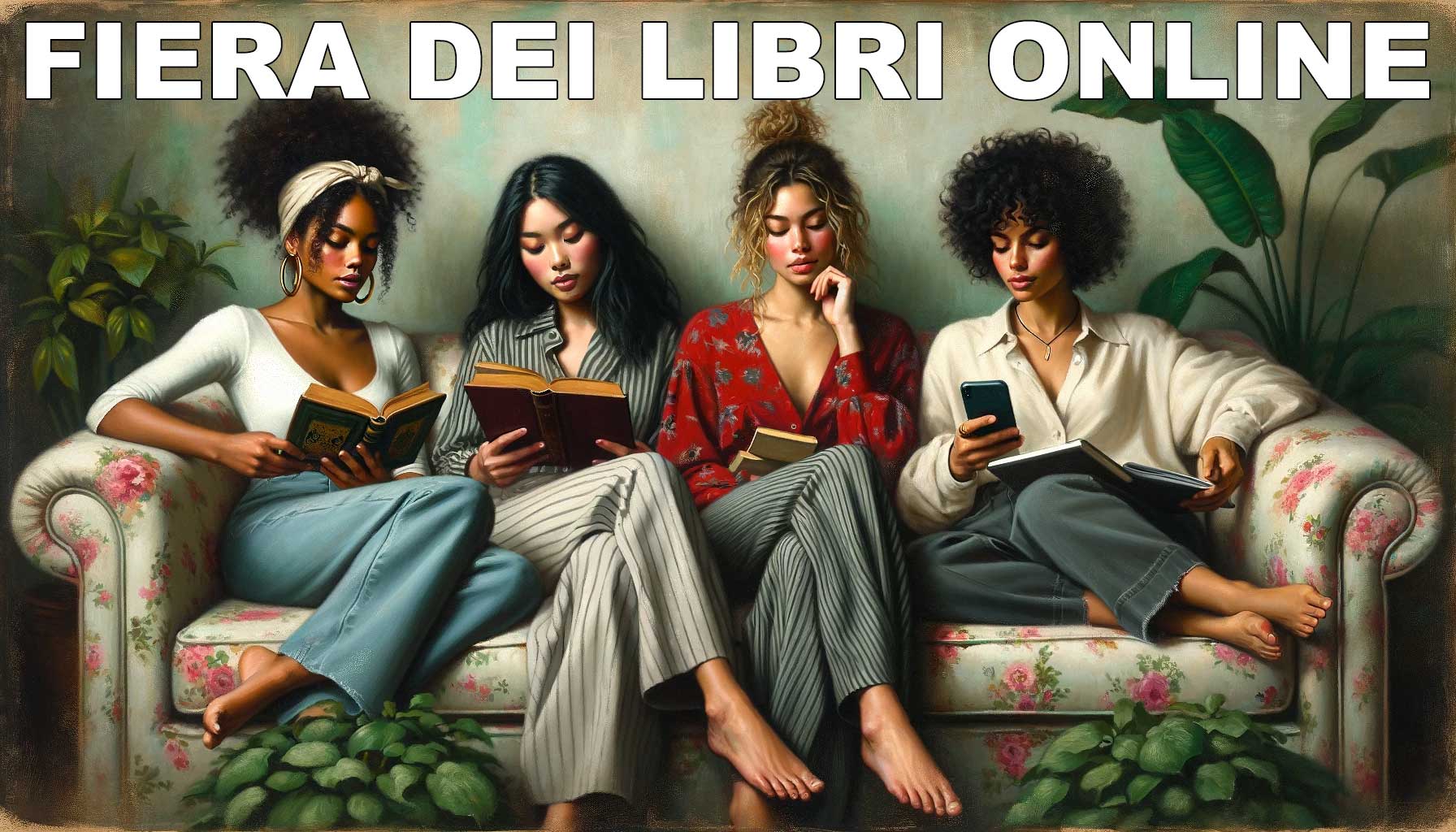

Riconoscente per il libro ricevuto, prometto che lo gustero’ parola dopo parola, sicuro di ricavarne emozioni e salutari turbamenti.
Grazie ancora.
Gaetano
Grazie per il libro, è veramente splendido. Ancora complimenti, Maria
Complimenti di cuore, ho letto il brano senza riprendere fiato. Concordo pienamente con chi ha scritto che dopo le prime parole sei catapultato in quei posti senti gli odori e vedi i colori. Mia nonna era di Portogruaro e lì trascorrevo le mie vacanze d’infanzia mi e’ sembrato di rivivere quei momenti. Mi piacerebbe ricevere in dono il tuo libro e leggerlo in un solo fiato.
Complimenti ancora, Paola.
Ricordare, immaginare, colorare i luoghi che rimangono nel profondo, eternamente nel cuore, con nostalgia assaporare il passato mai dimenticato.Complimenti
Ricco di immagini di un passato di cui facevano parte i nostri nonni e forse anche i nostri genitori, il testo mi colpisce molto anche per il linguaggio usato. Nel tentativo di parlare come “una volta”, il racconto ci catapulta a molti decenni fa, dove si viveva la fame, la povertà, e, come ampiamente sottolineato, la superstizione. Mi piacerebbe molto leggere il libro interamente, perchè mi ha riportato alla mente immagini ormai sepolte. Anch’io ho visto uccidere il maiale, anche se in modo diverso, o ho accompagnato mio nonno ai campi per tagliare l’erba. E’ un mondo che è anche un po’ mio e vorrei riviverlo.
poetico, nostalgico, malinconico…
bello !
Vorrei tanto poter ricevere una copia omaggio di questo libro. A chi devo rivolgermi?
Attendo risposta!
Gentile Maria,
mi lusinga molto la sua richiesta di ricevere il mio libro in omaggio, pertanto, sebbene le copie da destinare a questa iniziativa siano poche, ahimè, la invito a mettersi in contatto esclusivamente via mail con la Redazione indicando il titolo del mio libro e il suo indirizzo postale.
Saluti,
Giovanni Luigi Navicello
Gentilissimo Giovanni Luigi Navicello,
le abbiamo inviato l’indirizzo postale della lettrice. Se vuole può confermarci qui o via mail la ricezione. Grazie.
gentilissimo Giovanni….o Luigi?
ho ricevuto il libro e non aspetto che qualche minuto di
serenità per tuffarmi nella lettura.
grazie grazie grazie!
È un racconto che ci porta nella poesia delle nostre campagne, e ci fa conoscere quelli che sono i disagi ed i valori della vita contadina, non sottovalutando le superstizioni che provengono da lontano ma vengono sempre rispettate in tutte le nostre campagne.
Quindi la mentalità contadina, è sensibilissima – alle annate buone e alle annate cattive, all’andamento della salute e all’evolversi della vita in tutte le sue componenti fisiche e metafisiche. Specialmente nei tempi andati – ma ancora oggi esistono le credenze –circa i poteri magici di piante, animali e di determinati eventi di origine metereologica.
Ci fa conoscere i valori e i disagi dell’acqua che può rappresentare una disgrazia od una fortuna . “L’acqua si malediceva e si adorava come una donna capricciosa che ti promette” , riferita alle alluvioni o alla mancanza di acqua nei periodi estivi
Io che mi considero “un vecchio ragazzo di campagna” nel leggere la bellissima presentazione, ascoltavo simbolicamente in sottofondo una musica della Maremma Toscana che accompagnava quelle parole attraverso una poesia in ottava rima, cantata da poeti contadini.
Complimenti e tanti auguri.
Bravo Sergio,
mi piaci perchè non sai dimenticare quel romantico periodo di vita in campagna, che ora – purtroppo – non c’è più.
la tua collega e amica vanna socia auser
Caro Giovanni,
avevo tre anni il giorno che hanno ammazzato il maiale nella mia famiglia e mi hanno trovato solo a notte fonda. Dal terrore di quella urla, che non potrò mai dimenticare, mi ero nascosta in uno spazio strettissimo e buio tra una vecchia madia ed un muro pieno di muffa e umidità.
Il tuo modo di scrivere, incisivo ed essenziale, m’inchioda prepotentemente al passato. E mi rivedo nella stupenda immagine della tua copertina, in quel bambino pensieroso con quel nero alle spalle che ricorda il mio buio, con un destino che immagino simile al mio, in una storia che ti risucchia come un vortice, in una nuova notte che mi attende… a chiedermi ancora tanti perché. Chissà, forse una risposta potrà arrivarmi dalle tue parole.
Complimenti di vero cuore
Cinzia
Musica classica di sottofondo e le pagine di Navicello trasportano in un’altra epoca. Si viene letteralmente catapultati in una realtà diversa… potere della buona letteratura, quello di far sparire i limiti spaziali e temporali godendo di un’esperienza nuova, talmente reale da lasciare alla fine la sensazione di esserci stato davvero lì e in quel tempo. Bella anche la scelta stilistica.
Auguri.
Pal
Un’emozione forte, una sensazione di totale coinvolgimento. Le pagine di Navicello sembrano pennellate impressioniste dai toni pastello e dalla incredibile carica descrittiva. Il paesaggio campestre emana odori, profumi e sensazioni tattili vivide… i ciuffi di riso sui polpacci sono qui e ora.
Complimenti e grazie.
Elisa
Leggo e rimango sorpreso del “verbo” usato da voi che avete scritto. Lo credevo perso in semplicità d’informazione ed al contrario esiste ancora quel leggero sentore d’antico, quell’uso proprio di una lingua benedetta che sa sfumare preghiere e bestemmie e voglio fortemente questa notte non capire, ma ripetere le parole come insegnamento.
Cito senza nome poichè non è importante: “L’ultimo è lo scrittore, quel che crede il mondo bisognoso di parole… che almeno ringrazi chi gli crede!”
Spero d’averlo fatto.
Giovanni Luigi Navicello
Una pagina che riporta la mente indietro nel tempo, quando tutto si leggeva attraverso la natura, il cambio delle stagioni.
Belle immagini che scorrono davanti come in un film.
Si sente che fa parte del tuo vissuto, si avverte nell’intensità della descrizione.
Auguri per la ri-visitata infanzia.
Maria
Profumi di Emilia. In queste righe intense si riscoprono le vene di una stagione infinitamente poetica, abitudini e preghiere scordate sull’uscio di una generazione cresciuta tra campi e sudore.
Tutto sembra essere sistemato al posto giusto, pure il latrato di un cane rivolto agli sconosciuti(cosa che oggi pare in disuso), assume un senso vigoroso. E le stagioni stentate sulla pelle non lasciano il segno ma corrono via melliflue, cadenzate da tutto ciò che il mondo esterno offre con i suoi minuti carichi d’insetti, le sue ore percosse dal vento, i suoi giorni protetti a speranze. Speranze umettate da un Dio unico per tutti, più forte delle superstizioni e ligio nel rendere gli uomini puri fino allo spasmo.
Un’età ingiusta che restituisce al cuore il bianco aroma dell’infanzia.
Grazie all’autore.
parole che dicono molto più delle immagini.
il passato che ritorna nel presente.
molto bello ed elegante lo stile.
complimenti vivissimi,
ilaria
Trovo stupendo leggere questi scampoli di vita rurale dove ad ogni frase ne esce vita, vita semplice ma concentrata, intrisa di terra e animali, di superstizioni e tradizioni, ignoranza e sapere.
Leggendo immagino dei quadri, quadri che prendono vita e formano sequenze di una storia di altri tempi.
In bocca al lupo a Giovanni Luigi Navicello per il suo racconto.
Riflessione immediata sulla lingua utilizzata. Un salto del passato che ritengo un valore aggiunto nella narrazione. Sono altri tempi ed è un altro mondo: fatto di cose semplici, affetti, sentimenti genuini, ma anche povero. In queste righe riesci a dare dignità ad ogni più piccolo aspetto. Non solo ai protagonisti (sarebbe troppo banale), ma ad ogni piccolo animale, persino all’acqua che paragoni a una donna capricciosa. Righe decisamente riuscite.
L’ innocenza violata. Capita. E non ci riferiamo agli abusi carnali.
Anche la guerra puo’ farlo, coi suoi orrori e le sue tragedie.
Un bambino diventa improvvisamente adulto. Senza assaporare il gusto dell’adolescenza e della giovinezza.
Ma e’ un trauma, che lo segnera’ per sempre. Anche nelle sue valenze positive.
Ingiusta non e’ l’eta’. Ingiusta e’ la sopraffazione.
E l’innocenza puo’ restare. Seppur macchiata di sangue.
Gaetano
Lei ha colto esattamente il senso del titolo… quell’innocenza che troppo spesso ho visto violata in terre lontanissime tra loro. Un tributo troppo grande da pagare!
Qualora non lo avesse già letto, se ha voglia di ricevere una copia omaggio del mio libro, compatibilmente con la disponibilità delle copie omaggio, la prego di mettersi in contatto esclusivamente via mail con la Redazione indicando il titolo del mio libro e il suo indirizzo postale.
Giovanni Luigi Navicello
Complimenti verissimi ad un autore che sa quello che vuole trasmettere ai propri lettori.
E’ immensamente bello rivivere degli angoli della propria mente attraverso dei ricordi che vengono raccontati e che risvegliano le parti addormentate della nostra memoria.
Grazie.
Complimenti, per la capacità di saperci riportare ai tempi delle antiche tradizioni e alle attuali credenze della povera gente dell’Emilia che si riflettono anche nel campo agricolo. Essendo naturalista leggendo ho sofferto per quel maiale che veniva ucciso (secondo me in modo crudele), ma so che è inevitabile per la nostra sopravvivenza. Inoltre, mi è sembrato di vedere l’immagine delle risaie, il fiume Panaro che scorre ecc.. Questo significa che il tuo brano sa trasmettere emozioni intense come se realmente vissute davanti ai nostri occhi e molte volte ci si trova in un’età ingiusta come quella dei bambini per viverle. Saluti
Un complimento all’autore che ha descritto un luogo reale con la stessa eleganza e pacatezza dei termini con cui Terry Brooks narra il suo mondo fantastico e così mi hai portato in un mondo di sogno misto a realtà che mi ha fatto assaporare quei valori e quei gesti che poi non son così tanto lontano da noi..basta avvicinarsi alla campagna per scoprire che gesti/credenze sono ancora quelli. Complimenti
Che pagina! Senza ricordi non esiste il futuro, l’autore bravissimo, ci fa assaporare istanti di vita vissuta, rammentandoci l’autenticità, il candore, la semplicità, quella vera, che oramai si è perduta, ma che ci piacerebbe rivivere. Mariarosa
le parole scorrono e ….alla fine mi è rimasto un nodo in gola, con la
voglia irrefrenabile di proseguire.
attendo il libro in dono, se vuoi e complimenti!
La cosa bella di questo brano è che mi ha rapito con la mente in un mondo in cui la materialità diventa poesia, in cui c’è una commistione uomo-natura che sembra essersi persa.Il cibo,la terra,le piante,gli animali,il brulicare della vita intorno a noi, le nostre necessità primarie di vita, il mangiare prima del ragionare , un mondo in apparenza semplice.Mi piace, ci fa tornare indietro ma non mitizza nulla.La realtà era quella, fatta di setole di maiali e di dettagli materiali che diventano vera poesia.Complimenti,è il tipo di storia che mi piace.Il titolo lascia presagire amari ricordi e una situazione che diventa drammatica.
Mi piace il tuo modo di narrare che trovo molto poetico. Mi sembra di trovare nella pagina che ho letto una profonda armonia, una saggezza di cose antiche ancora oggi vere, una ricerca del passato che si fa presente. Complimenti, Lenio.
In questa pagina le immagini scorrono come in un film, la trama riporta a paesaggi di un tempo ancora presenti, ai ricordi della famiglia e agli affetti più cari che hanno l’umore della semplicità vissuta con pienezza e armonia.
Una storia da leggere anche per riflettere sui valori, sulle tradizioni e le radici profonde di ciò che è stata ed è la condizione umana.
Vivissimi complimenti! Un caro saluto
Gianna
..é una serata calda..ho aperto le persiane di questa vecchia palazzina nel centro storico di una piccolo paesino di provincia. Da fuori mi giungono i suoni piacevolissimi del concerto di un cantante d’ opera che a tratti si mischia col rumore delle machine in transito sotto casa. …una saracinesca che scende…i rumori dei bichieri del bar di fronte…balbettio di voci dei passanti…In questo quadro scorre la lettura di un testo che si plasma e s’ intreccia ad un ambiente assai simile…simbiotica l’ atmosfera. Mi è piaciuto tantissimo leggerla…Complimenti sinceri, Manuela
Leggere e in un attimo ritrovarmi bambina con lo zio che mi portava ai campi in carriola. Istanti che ritornano dalla memoria lontana, nella campagna emiliana. Cosa mi sono persa? Ecco qui cosa mi sono persa, quando mi hanno portato in città ed ero ancora piccola. Ma queste storie, sono le storie che mi raccontavano i miei, sono autentiche!
L’emozione scaturisce grazie a un descrivere di immagini che sembrano uscire dalla nebbia e, nel narrare poetico, riprendono vita. Così, quel grugnire del maiale prima del macello, è possibile sentirlo.. vedere le mani indurite dal lavoro della terra, le superstizioni messe in atto. Un mondo che sembra non essere esistito mai, ma che invece è stato e ci ha donato la vita. Ecco quindi quale è la magia del libro e la sua bravura, Sig. Navicello: l’averci restituito le nostre origini, per non dimenticare mai.
Complimenti vivissimi!
Ars
Mio nonno, la mia infanzia trascorsa con lui e i suoi racconti hanno ispirato profondamente il mio romanzo… storie e persone di un tempo che sembra così lontano ormai…
Se ha voglia di ricevere una copia omaggio del mio libro, compatibilmente con la disponibilità delle copie omaggio, la prego di mettersi in contatto esclusivamente via mail con la Redazione indicando il titolo del mio libro e il suo indirizzo postale.
Giovanni Luigi Navicello
Me lo immagino e lo vedo davanti a me il comune di Pradello, i suoi contadini e la grande famiglia. Una storia reale, viva da quel poco che ho letto. Un racconto che trasmette gli antichi valori della famiglia, la lealtà e il mutuo soccorso, nonché le tradizioni. Valori che spesso oggi sembrano dimenticati.
Dalle poche righe riportate però non sono riuscita ad interpretare il titolo, forse avrei bisogno di più pagine. La curiosità c’è tutta.
Complimenti all’autore per aver saputo ricreare quell’atmosfera.
Saluti.
Stefania
complimenti anch’io ho letto solo una pagina ,ma e’ bellissimo ,semplice ,chiaro che ti fa vivere anche gli ambienti e i luoghi.Davvero bello. Augurissimi
Ho letto una pagina, quanto basta per entrare a fare parte della storia che l’autore racconta con semplice armonia. E le immagini che sfilano l’una dietro l’altra, mentre leggi riportano qualcosa di familiare. E l’emozione è grande! Complimenti vivissimi.
Cordiali saluti
Marinella (nonnamery)
Innanzitutto i miei complimenti per il Premio Speciale Molinello 2009.
E poi…e poi sono rimasta affascinata da questa pagina.Più che parole,delle vere e proprie immagini.Colori e suoni che mi hanno catapultata in una terra che non conosco, eppure, per un attimo mentre leggevo, ne ho fatto parte. Mi sono sentita un tutt’uno con i protagonisti, come se io fossi là.
Condivido in pieno ciò che ha scritto la Grande Alda Merini; La scrittura deve diventare una mano che si tende verso gli altri e quindi una cosa facile da leggere e che invade il nostro profondo. Io l’ho sentita quella mano,non solo ha stretto la mia, ma mi ha invaso…come una carezza…
Un libro che leggerò sicuramente.
Un saluto.
Anna Laura