
L’incontro –
1937. La primavera –
Avevo otto anni quando incontrai Raoul, per caso; era il soggetto, l’artefice di quello che io guardavo, il suo lavoro.
Un lavoro umile – spaccava i sassi ! -, per renderli assimilabili alla massicciata che si sarebbe formata e consolidata col passare dei carri.
Senza darlo a vedere si era accorto della mia presenza e dimostrava di accettarla. Fu mio l’imbarazzo e mi venne di giustificarmi cercando di dire qualcosa. Mi fece giuoco, nel momento in cui avvicinava a sé i sassi, un suono che veniva da poco lontano: un ripetitivo croh, croh, inconsueto. “Cos’è questo rumore” dissi, “l’è il fagiano” rispose. “Non so cos’è…” e lui “…selvaggina!”; “ne so quant’e pprima…”, aggiunsi. Il ghiaccio era rotto, ma non significava aver superato la distanza che l’umana deferenza metteva fra me e quel signore che, seduto per terra, a gambe larghe, spaccava i sassi. Quando avvicinò di nuovo un mucchietto, approfittando dell’interruzione dei colpi, mi domandò di chi ero, risposi con il cognome e disse “…ah”, come avesse capito. Lì, a quel tempo, era già una presentazione. Più tardi, quello che scaricava i sassi lo chiamò, allora seppi che il suo nome era Raoul.
C’era un’altra attrattiva da quelle parti che di lì a poco avrebbe preso il sopravvento: La Parata.
Era un fiume anche se un cartello lo definiva torrente; scorreva con un’acqua limpida e profumata. S’incontrava poco fuori città, cinque minuti di bicicletta e già era piena campagna. Formava delle piccole chiuse dove tutto l’anno le donne lavavano i panni sbattendoli contro trovanti di pietra che nel magico giugno servivano ai ragazzi per tuffarsi. L’acqua arrivava al ginocchio, ma era sufficiente per magnificare le più “spericolate” immersioni ed emozioni balneari. Non era vietato bagnarsi, ma di fatto lo era perché fra quei nudi innocenti ce n’era qualcuno più grandicello che se non offendeva proprio il pudore (erano sempre tutti maschietti), faceva un po’ la differenza. Così l’arrivo della “Pula”, la guardia municipale, completava il quadro con il fuggi fuggi nell’altra sponda, verso i campi, con i panni in mano. Fu proprio Raoul, che lavorava lì, sulla strada, a farmi notare il senso di quell’intervento repressivo in nome di un “ordine” che proprio con lui doveva diventare oggetto di animato dialogo per una vita intera.
Raoul, l’uomo di cui mi accingo a raccontare la storia, ha oggi 77 anni, un anziano ben portante dai lineamenti omologati alle pietre che ha trattato per una vita, austero e disponibile con un sorriso profondo di età e di saggezza. Quel ragazzo di tanti anni fa ha fatto della vita la sua arma migliore usandola con profitto per sé e per gli altri. Oggi non lavora più con le mani; le doti del suo cuore e della sua amabilità lo hanno trasformato per me nel mio migliore amico, per se stesso e per chi ha la ventura di incontrarlo in un uomo che vale la pena di ascoltare.
Sorprendente la linearità della sua esistenza, nella quale, in tutti i momenti non è mai stato né il genio, né il super uomo, ma sempre un soggetto normale. Certo, di alcune qualità occorre fargli credito: il buon senso, l’assoluta mancanza di presunzione e poi due specialmente, una volontà ferrea che tale si palesa specie quando i risultati sono lontani e faticosi e, prima fra tutte, la saggezza, dono di cui la natura gratifica solo certi individui, perché non arriva a caso, si costruisce con il sacrificio e la buona disponibilità a tollerarlo.
La seconda volta che parlai con Raoul, fu proprio uno di quei giorni che andavo a vedere i ragazzi al bagno. Io non lo facevo, anche se morivo dal desiderio. Mi avvicinai a Raoul in un momento di distacco dai bagnanti e siccome ci eravamo già rivolti la parola, dissi “buongiorno”.
E necessario ricordare che i rapporti sociali di allora, molto diversi dalla mistura attuale che ha trasformato il concetto di dignità in arroganza, erano solidi e inderogabili, chiari, condivisi perché sostenuti da considerazione e rispetto. Tutto – cose, vantaggi e reputazione – a qualunque strato sociale appartenessi, dovevi conquistartelo e meritartelo. C’era, nelle differenze, una sorda uguaglianza cui tutti avevano il diritto di accedere: lasciapassare era il rispetto umano.
Raoul rispose al saluto a suo modo, annuì col capo e mi rivolse appena un sorriso a bocca stretta accompagnata da un’occhiata che mi è rimasta impressa. Intendeva dire che, se non avessi sgarrato, poteva andare. La conferma un attimo dopo, mentre interrompeva con il martello per avvicinarsi il mucchietto disse: “…ma lei a scuola ci va?”, “si, faccio la quarta!”. “Ah… bravo!”. Con questo apprezzamento finì il nostro secondo incontro, con un sorriso, come nei temi di allora “…felici e contenti di…”. In effetti quell’interessamento alla mia persona da parte di chi riscuoteva il mio, suonò al di fuori dei miei ambienti, scuola, compagni e famiglia, come una piccola complicità dalla quale ricavavo un senso di crescita, di autonomia, che mi lasciava contento e sentivo di dovermela tenere per me. Erano forse i sintomi della nascita dell’amicizia, uno dei sentimenti più alti proprio perché ne sono poco riconoscibili le cause dell’insorgere e si alimentano anche a distanza di anni, dopo lunghi periodi di assenza.
Complice di quella partecipazione il giugno inoltrato, la scuola finita, la passeggiata libera in bicicletta, i ragazzi alla “Parata”, gli odori della campagna che, all’apparenza normale, risvegliano tutte le migliori attitudini di cui la primavera è mezzana. Non mi rendevo conto, ma con certezza ero parte di quella primavera. E anche Raoul.
L’incontro con Raoul non significava conoscerlo, tanto meno poterlo praticare. Il problema della conoscenza fu presto colmato quando la cosa trovò una via ufficiale, perché le nuove identità annullavano quell’innocente segreto legame, sorpassandolo. Di fatto però si chiarirono le posizioni per cui se mia madre mi avesse visto fermo attorno a Raoul non mi avrebbe più fulminato con un “cosa fai lì… vieni via!”.
Lo scenario in cui si svolse il rito della conoscenza è quello della motivazione delle presenze in una società tradizionale e ottocentesca, ma già toccata da inquietudini di riscatto dalla esasperazione delle differenze e in attesa di un futuro imminente e incombente. Il futuro era rappresentato dall’imprescindibile avvento della crisi, della crescita, dell’entusiasmo e del conseguente incauto ottimismo. Purtroppo questo superamento costò vicende drammatiche, ma era ciò che i tempi proponevano e a quelli non si sfugge.
Prima di quegli eventi che hanno sconvolto il mondo, da noi si viveva un periodo di assestamento post-risorgimentale con autentica pacificazione degli animi, intesa come reciproca comprensione, accettazione di pur esistenti squilibri economici, riconoscimento di un diritto e professione di dignità di cui lo stato sociale si proponeva come garante. Questo è il senso dello stato dell’ordine di allora, perché alcune manifestazioni di intolleranza erano marginali, fastidiose e invadenti, ma solo in superficie. Gli animi erano liberi, liberi nelle loro convinzioni di fondo e quindi sereni nella pienezza e consapevolezza dei ruoli di ciascuno. Un’Italietta tutto sommato pulita e ordinata nelle persone, invidiata da tutti, anche se gli eventi hanno dimostrato di non essere preparata per i tempi tremendi che si paravano all’orizzonte: “la guerra e dintorni”… ! Ma l’Italia poteva non esserne coinvolta? 1 cinquanta anni successivi hanno dimostrato che i portatori di quegli eventi nel mondo non eravamo noi!
I cosiddetti cattivi, l’Italia, la Germania, il Giappone, battuti sul campo di battaglia, distrutti e mortificati nello spirito, annientati economicamente, dopo un ragionevole periodo di recupero hanno riacquistato una posizione determinante nelle istituzioni, nell’economia, nella politica e, quel che più conta, nel prestigio. Ciò non solo riconosce e assegna a questi paesi il diritto al riconoscimento di un primato storico sociale assoluto, nonostante le esigue entità territoriali, ma motiva l’avversione che altre collettività hanno nutrito e che per storielle prevaricazioni hanno preteso esercitare, appunto con la guerra. Il tutto in nome di un frainteso senso democratico, ben attento ai propri confini economici e in relazione a determinati scopi. La regola? “O fai come dico io… o fai come dico io”. Non vorrei far torto a Raoul, che in dieci lustri di conversazioni ha dimostrato la capacità di superare il significato degli eventi che si esaltano e si spengono nella cronaca e di arrivare al nocciolo del problema, che la storia spesso separa con decenni rimandandone, quando possibile, la lettura.
***
Dal libro Raoul di Giorgio Panero.

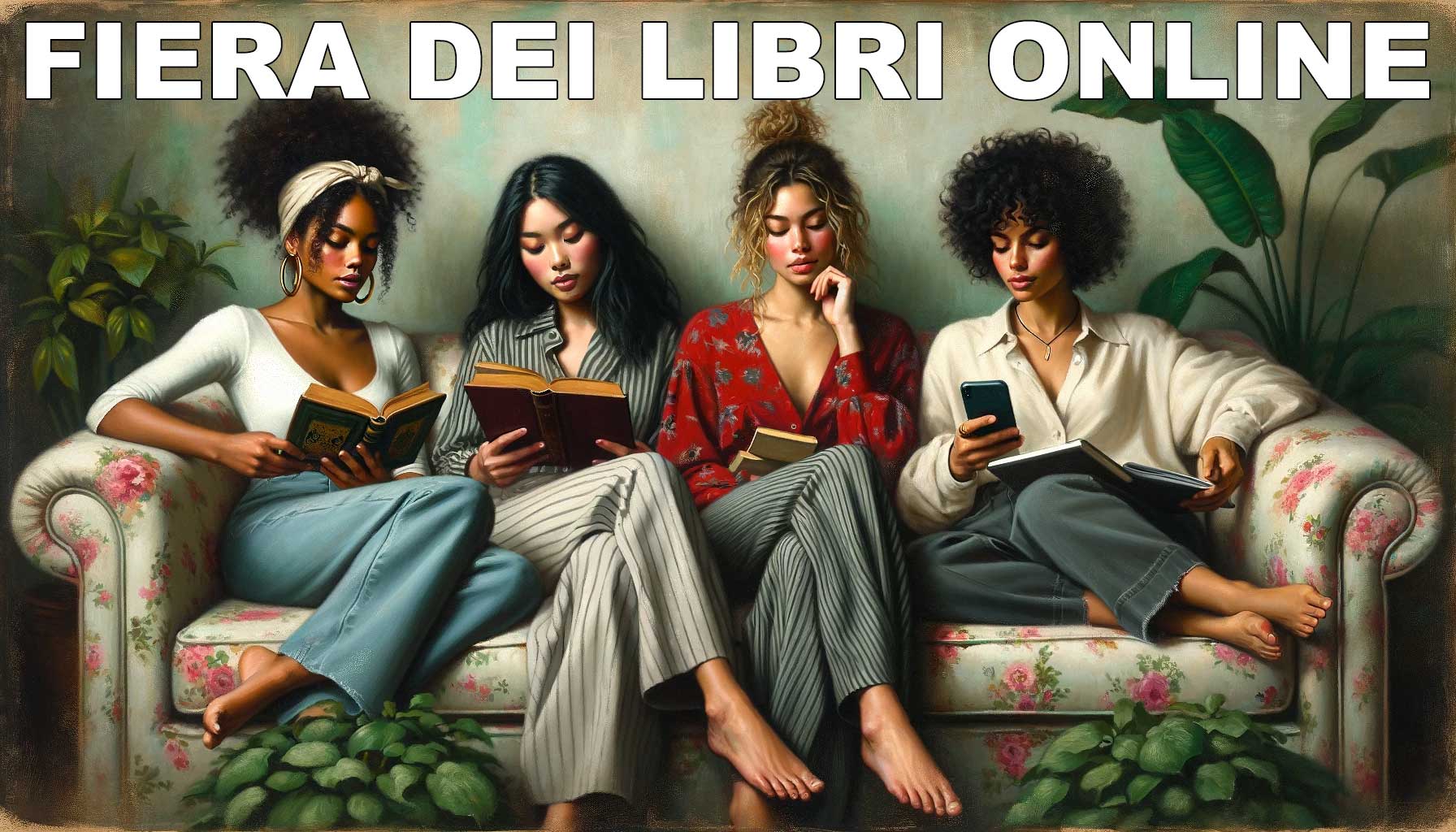

Chi uomo non vorrebbe immedesimarsi in Raoul come persona saggia ed intelligente, che quando parla tutti si fermano ad assorbire la profondità della persona.
Complimenti vivissimi.
Mi piacciono le righe che ho avuto modo di leggere, descrivono con tanto amore una persona semplice e forte che a tutti piacerebbe incontrare per ascoltare e per farsi ascoltare complimenti, ho avuto la sfortuna di non aver conosciuto i miei nonni o di averli persi molto piccola e cosi’ nessun uomo con i capelli bianchi mi ha acoltata ovvero mi ha regalato racconti e storie di tempi lontani e per i quali provare nostalgia
mi piacerebbe leggere per intero il suo libro
Raul è l’uomo ideale, almeno per me, silenzioso, ma molto saggio.
la descrizione del personaggio è fatta molto bene, molto bello lo stile narrativo.
complimenti, ilaria
Raul mi ricorda il nonno che un po’ tutti vogliamo. Quello giovane della nostra infanzia, che ci strega con le sue mille attività, che ci ammalia con le sue poche parole. Quello che staremmo per ore a guardare, anche senza dire nulla, perchè anche il silenzio, insieme a lui, diventa importante. E il nonno vecchio della nostra maturità, che appunto più non lavora, ma si porta addosso tutti i suoi anni e vorremmo sederci accanto a lui, sempre su un gradino più basso, ad aspettare insieme il trascorrere del tempo. E’ la storia di nostro nonno, quella che nessuno, nemmeno lui, ci ha mai raccontato, per paura di farci stare troppo male. Perchè la guerra non è una storia da raccontare a dei bambini, perchè allora le cose erano diverse e il sudore colato su ogni pietra rotta assumeva un significato che oggi non c’è. Con il sottofondo di rumori tipici solo del passato, tutti vorremmo ascoltare la storia di Raul.
Un racconto molto poetico e ben descritto, già sento quegli “odori di campagna ” e vedo Raoul chino al suo lavoro.
Un affresco di un periodo duro e difficile che però aveva a cuore la famiglia e l’onesta.
Mi piacerebbe approfondire la lettura.
Intanto per ora mi ha fatto un ottima impressione e apprezzo il suo stile narrativo. Buon lavoro.
Stefania C.
Bella questa descrizione di una vita di alti tempi.
Oggi di presunti super uomo se ne trovano troppi ed è difficile che una persona voglia essere “normale”, troppi prototipi, troppi paragoni, troppa tv.
“I rapporti sociali di allora, erano solidi e inderogabili, chiari, condivisi perché sostenuti da considerazione e rispetto”, questa frase rispecchia molto le differenze di quel periodo con quello attuale.
Credo che il proseguo di questo libro sarà molto interessante e ricco di buonsenso.
Ci sono i Raoul, eccome! Ne ho incontrati e ne incontro ogni volta che mi rendo “disponibile”, che dimentico chi sono e ascolto, conscia che ricordare spesso non serve, ma senza il ricordo non può esistere il presente ne il futuro.Però se questo spaccato che Paolo ha vissuto ci insegna che i ricordi si immergono nel mare e come maree ritornano nel cuore, a paolo :GRAZIE!, Mariarosa, alias la tigre.
purtroppo oggi non ci sono più i valori di una volta!!quante volte abbiamo sentito questa frase?bè anche nei miei pochi 20 anni penso di averla sentita un centinaio di volte.Ogni volta una faccia diversa,con più rughe,chi con meno,ma tutti con il ricordo di un tempo migliore alle spalle.Io non ci credo.Anche oggi si può star bene.Con poco,con nulla..l’importante è la propria saggezza.Riproponiamoci di essere tutti un po’ il Raoul moderno.Allieteremo così le giornate altrui..e le nostre.
Le faccio i miei più sentiti auguri,sperando un giorno di poter leggere la storia del Suo Raoul.
un saluto!
Raul e’ la “vetrina” di un’epoca che, passata, si vorrebbe nel futuro. Non per le sue incomodita’, ma per i suoi valori.
Panero lo ha ben compreso e dispiega la nostalgia del tempo in cui la persona viveva di doveri e la felicita’ era di compiere bene il proprio.
Si stava meglio quando si stava peggio. O, piuttosto : i beni (corruttibili) han sostituito il Bene. E cosi non va.
Gaetano
Gentile Giorgio,
non sa cosa darei per incontrare una persona come raul: uomo di pochissime parole ma dalla grande anima.
Viviamo in un mondo dove il “bla bla bla” è talmente tanto presente da costituire il leitmotiv di uno spot pubblicitario…
Sono una persona pacifica di natura, ma quando vengo a contatto con chi mi riempie la testa di chiacchiere, impazzisco. In questi momenti tornerebbe utile un telecomando in modo da cliccare sul tasto MUTE e azzittire in questo modo il nostro interlocutore…
Spero tanto che il Suo sia un romanzo autobiografico: se davvero ha avuto e continua ad avere la possilità di vivere accanto a un dono del cielo come Raul, Lei può considerarsi la persona più ricca dell’universo.
Quest’uomo saggio che si “massacra” di lavoro e che non si abbatte perché solo con i sacrifici si ottengono i risultati più importanti, è semplicemente meraviglioso.
Sperando di poter leggere il Suo romanzo per intero, le faccio tanti COMPLIMENTI!
Maria Grazia