UN UOMO TENACE –
“Tripoli, bel suol d’amore, ti giunga dolce questa mia canzon”. –
Erano i versi di un canto che dava speranza a tanti Italiani, la maggior parte precari o reduci dalla prima guerra mondiale (1915 – 1918) che, in cerca di fortuna, si avventuravano nel credo politico del momento, inteso a formare del Regno d’Italia un Impero coloniale.
Erano gli anni venti.
L’Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, l’Olanda, quasi tutti gli Stati dell’Europa occidentale godevano già da qualche tempo di quest’espansione territoriale nei vari Continenti: Africa, America del Sud, medio ed estremo Oriente.
Tali conquiste, motivate da uno spirito di civilizzazione delle terre lontane, mirarono a espansioni territoriali e a un ritorno, in termini economici, con lo sfruttamento agricolo, forestale e minerario che promosse in Europa il commercio di tè, spezie, oro, diamanti. Queste terre occupate funzionarono da testa di ponte per altre conquiste.
Lo scopo, in un certo qual senso, fu raggiunto. I popoli, assoggettati già nel seicento e nel settecento, avevano assorbito lentamente la civilizzazione europea al punto che alcuni indigeni divennero, in tempi più recenti, cittadini europei. I colonizzatori seppero sfruttare quelle terre conquistate, anche a costo di vite umane. Esse furono falciate sia dalle popolazioni autoctone sia dai Pirati che all’epoca, seguendo le rotte dei velieri commerciali e militari, ne razziavano le merci o addirittura le stesse navi.
Stessa cosa si era prefissata l’Italia mussoliniana, fascista, nello stringere patti d’alleanza con la Germania hitleriana, nazista. Già nel 1912 aveva conquistato la Libia, occupando la Tripolitania e la Cirenaica, che da alcuni secoli era sotto l’Impero turco, iniziando quella espansione territoriale che l’avrebbe portata a diventare un impero coloniale.
“Tripoli sarai italiana, sarai italiana al rombo del cannon”.
Al ” … bel suol d’amore”, seguiva la strofa “sarai italiana al rombo del cannon”. Una conquista, quindi, non motivata da principi umanitari e di civilizzazione, bensì di sudditanza, di sottomissione e d’incorporazione della Libia, denominata in seguito “quarta sponda”.
Migliaia di giovani italiani ricevettero la “Cartolina precetto”, altri chiesero di partire volontari per conquistare altre terre da annettere alla Patria e garantirle il nome di “Impero”. Il Duce fu la loro guida; la sua parola li entusiasmava. Madri, mogli e figli piangevano alla partenza dei convogli o delle navi che portavano i loro giovani eroi verso terre lontane: l’Africa, la Russia, l’Albania. A migliaia morirono sui campi di battaglia; le loro lacerazioni furono imbrattate dalla sabbia del deserto in Africa, mentre il sangue dei feriti e dei moribondi formava pozzanghere vermiglie sulla candida neve di Russia. Decine di migliaia di giovani non fecero più ritorno alle loro case; i volti dei loro congiunti erano cosparsi di lacrime per una morte così assurda. Vedove, promesse spose, orfani, e anziani genitori si videro privare del proprio unico bene.
Come in ogni guerra si assistette a scene d’orrore e punizioni per i ribelli. Molti musulmani eminenti e oppositori furono catturati e resi innocui. Accadde, come in tutte le guerre, che i conquistatori furono motivati da ragioni di padronanza e di libero arbitrio, fino a quando la razionalità e il motivo principale della conquista non prevalsero e ripristinato l’ordine e la legalità.
I primi coloni giunsero dal Veneto, poi da altre regioni italiane, e dalle vicine colonie francesi dove molti di loro si erano in precedenza stabiliti, portando esperienze artigianali e professionali diverse. A molti furono affidati ettari di terreno denominati “concessioni”, poiché si trattava d’appezzamenti provenienti da occupazione bellica, e quindi sotto la tutela del Governo italiano; terreni che in seguito furono trasferiti di proprietà a coloro che li avevano riscattati con il proprio lavoro.
Erano estensioni sabbiose, più o meno ampie, prive di coltivazioni e di acqua. I Coloni italiani furono persone coraggiose che, con le loro famiglie, incominciarono a trivellare pozzi, per fornirsi di acqua, costruendo alti tralicci di ferro sormontati da una grande ruota elicoidale che, azionata dal vento, dava energia a una pompa sommersa; erano i “pozzi artesiani”. L’acqua sgorgava in superficie ed era avviata in grosse vasche di raccolta, in cemento, capaci di contenerne ettolitri. Essa serviva sia per irrigare i campi, che per trovare refrigerio dalla calura nelle calde estati, cui la maggior parte di loro non era assuefatta, con l’immersione saltuaria a uso piscina.
Con gli aiuti economici e tecnici dello Stato italiano, essi costruirono interi villaggi. Sorsero abitazioni ampie a seconda delle esigenze familiari, depositi, ripari per il bestiame; quei contadini trasformarono, in pochi anni, tutta la striscia costiera libica in un giardino lussureggiante.
Orti, uliveti, palmeti, il grano maturava al sole caldo e i frutteti si espandevano in tutte le zone. Le arance, i mandarini, i limoni e agrumi in genere, le albicocche, l’uva, le prugne, i cocomeri e i meloni, e poi le fragole, i gelsi, i datteri e le banane, tutta frutta bisognosa di sole e calore aveva trovato in quelle “concessioni” il suo “habitat” naturale; il profumo e il sapore di quella frutta maturata sulle piante rimarrà solo un lontano piacevole ricordo.
I lembi di spiagge lungo le coste furono bonificati e resi abitabili, trasformati in pontili, panchine, bastioni. Nelle insenature naturali sorsero porti ampliati artificialmente. Strade costiere collegarono le varie cittadine e villaggi ai due principali capoluoghi.
I giardini cominciarono a espandersi lungo le coste, verso le città, con fontane e piccoli monumenti, alberi da ombra che emanavano frescura per i passanti e le mamme che passeggiavano con le carrozzine dei propri bambini. Palazzine, ville, chiese, banche, attività commerciali e finanziarie sorsero nel giro di pochi lustri; furono costruiti cinema, teatri e persino un Casinò.
(…)
Il 29 ottobre 1922 alle ore 12.55, il Re Vittorio Emanuele III affidava incarico a Mussolini di formare il nuovo Governo.
Tra le sue ambizioni vi era quella della creazione di un Impero che portasse l’Italia a essere una Nazione importante e rispettata. La Libia fu il suo primo obiettivo verso il quale furono incanalati investimenti d’uomini e mezzi. Poi sarebbe stata la volta dell’Etiopia, dell’Egitto e così via.
L’Italia era quindi in fermento e gli Italiani fecero affidamento nel programma presentato dal Fascismo; conquiste volevano significare lavoro e benessere per tutti. Dopo circa quattro anni in ferrovia, durante i quali era stato allietato dalla nascita di Assunta, giunse voce ad Antonio della richiesta di lavoratori “volontari” per l’Africa italiana. Ritenne tal evento una mossa audace da intraprendere, rischiosa, ma nel frattempo allettante per mirare a un futuro migliore. Ebbe dei dubbi; con la moglie e due bambini verso l’ignoto, di là del mare, in terra africana. Ne parlò con la consorte, ma dovette decidere da solo, come sempre. Lasciò il lavoro presso le Ferrovie e, fiducioso nell’aiuto dell’Onnipotente, decise di partire per la Tripolitania dove, come auspicato, l’avrebbe atteso migliore fortuna. Aveva trent’anni, l’età in cui l’uomo è ormai maturo per prendere quelle decisioni dalle quali dipenderà il proprio futuro.
Chiese di poter lavorare a Tripoli, la città dove aveva sede il Governo italiano d’occupazione di quel grande scatolone di sabbia, com’era nota la Libia, a causa dell’immenso deserto che dal Mediterraneo s’estendeva fino ai confini col Sudan, e dall’Egitto a quelli con la Tunisia e Algeria.
Il viaggio fu lungo; sulla nave s’incontravano anche dei militari che andavano a stanziarsi nelle caserme tripoline e, nel frattempo, davano fiducia e tranquillità ai passeggeri emigranti.
Trovata una prima sistemazione, tornò a prendere la famiglia, con la quale arrivò a Tripoli nel giugno 1928. Aveva un bambino di sei anni, Gregorio, e una bambina di un anno, Assunta. Era partito per migliorare la propria posizione economica e sociale, convinto a lottare per superare quella scala di valori che formano l’uomo e la famiglia; era disposto a svolgere qualsiasi tipo di lavoro, conscio di – come afferma anche il sommo poeta Dante – ”Quanto di sale sa lo pane altrui, lo scendere e salir l’altrui scale”.
Uno dei più grandi teatri, il Miramare, distrutto poi. durante la seconda guerra mondiale, era in costruzione proprio nel 1928 sul lungomare di Tripoli, dirimpetto al castello medievale dedicato a San Giorgio. Fu in questo contesto che fu offerto ad Antonio il suo primo lavoro; quello cioè di collaborare alla costruzione di quel gran teatro dalla vista sul mare. Lavoro pesante per lui, non più abituato a fatiche fisiche. A casa lo attendevano la moglie e due bambini presso una modesta abitazione. Furono situazioni difficili; le ore di lavoro giornaliere non avevano limite; le attività andavano sviluppandosi e c’era bisogno dappertutto di personale. Finita la sua attività quotidiana al Miramare, continuava la giornata lavorativa con altri impegni. Fu così che iniziò a mettere da parte qualche risparmio. La sera faceva la “maschera” al cinema: così era chiamata la persona che controllava i biglietti all’entrata nelle sale. Tornava a casa stanco dopo aver trascorso una giornata di lavoro, anche se vario, per aver sopportato oltretutto un clima cui non era abituato.
Oltre quaranta gradi all’ombra affaticavano il fisico più di quanto normalmente accadeva in Sicilia.
Le giornate peggiori le viveva però quando iniziava quel vento che proveniva dal deserto, il ghibli. L’aria si tingeva di giallo; era la sabbia fina che il vento trasportava, invadendo anche le città costiere, dalle dune che cambiavano forma e locazione. Iniziato il suo percorso, non si arrestava prima di tre giorni e altrettante notti. Superato il quarto giorno senza essersi calmato, il vento proseguiva la sua corsa per altri tre giorni. La sabbia entrava nelle case attraverso le minime fessure degli infissi chiusi anche ermeticamente. I polmoni vivevano di quell’aria; spesso si lavorava mettendo un fazzoletto davanti la bocca e il naso, legandolo dietro la nuca.
(…)
Dal libro Il ritorno di Giorgio Vindigni

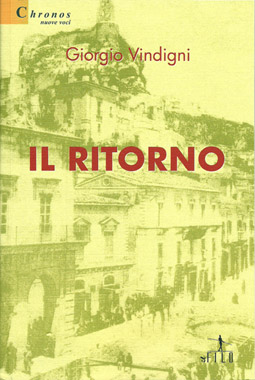
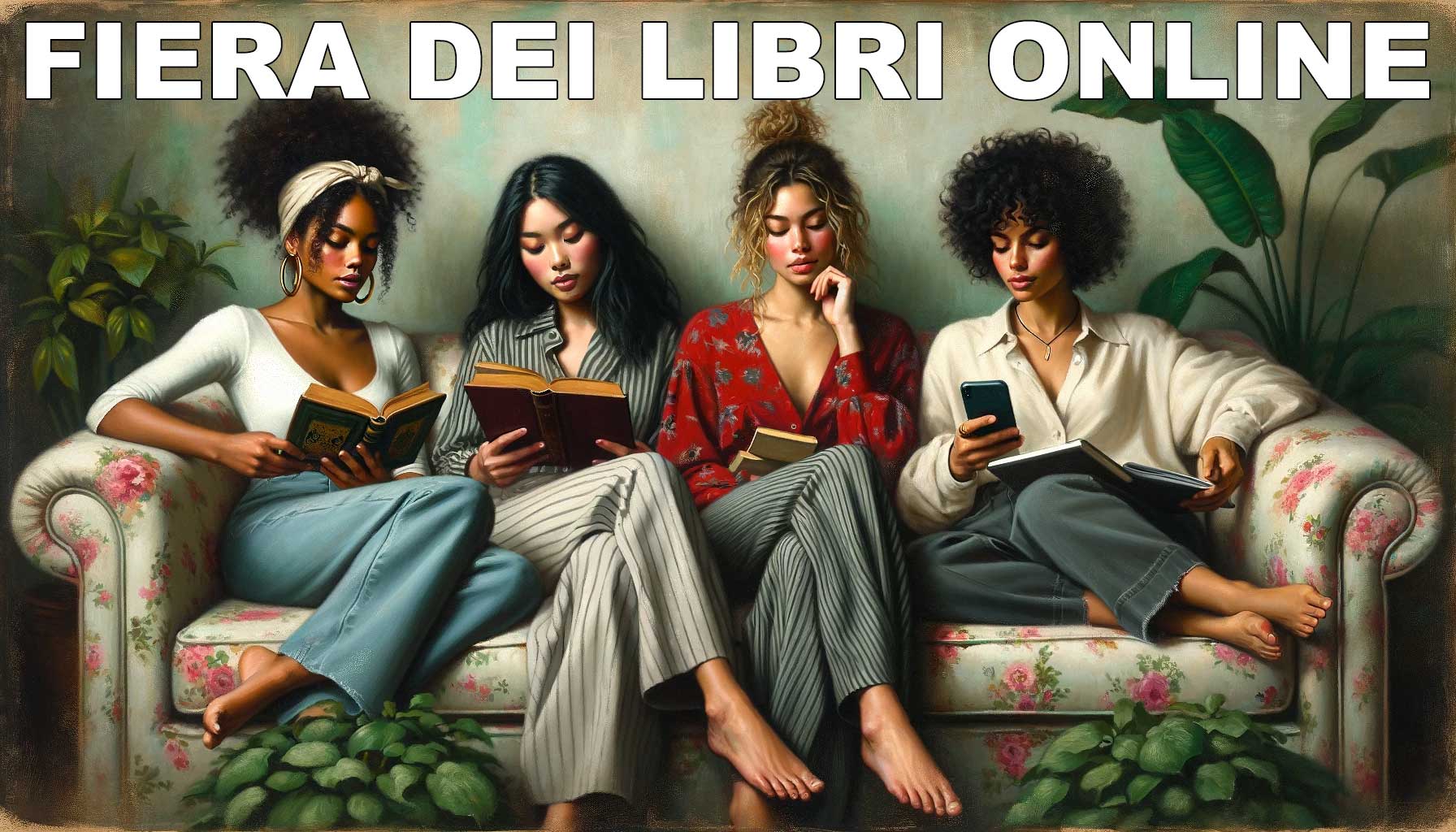

Ho letto tutto d’un fiato “Nucy”, il libro che completa la tua trilogia, Giorgio. Questo, più degli altri , mi ha fatto rivivere gli anni trascorsi a Tripoli quando era nel suo pieno splendore e anche quando purtroppo cominciava a porre dei limiti alle nostre giovani esistenze per i noti eventi bellici del ’67 e del ’69. Questo libro mi ha fatto conoscere profondamente la tua parte emotiva ed è stato come assistere ad un film (di quelli a lieto fine) dove l’amore vince su tutto ed i protagonisti catturano la simpatia degli spettatori. Sono contenta di avere in bella vista la tua avvincente trilogia. Non escludo di rituffarmi, di tanto in tanto , nei tuoi racconti e di farli conoscere ad altri che non hanno ancora avuto l’occasione di leggerti. Grazie!
Cara Mariella, con la tua recensione mi hai commosso.
Mi hai convinto di aver raggiunto il mio scopo: far rivivere i tempi vissuti nella nostra bella Tripoli. Grazie per le tue espressioni che hanno toccato il mio cuore. Un abbraccio.
Riccardo Chisari
Caro Giorgio, è un onore per me pensare di poter esprime un giudizio sul tuo operare letterario. Io scribacchio qualcosa per tenermi a galla quei quattro ricordi di gioventù. Fatti senza alcuna importanza, ma che per me sono state parte del quotidiano e man mano che le immagini vengon alla mente le butto subito giù.
Tu sei un vero scrittore. Un attento osservatore, uno di quelli, con tanto di cappello sono documentati su tutto. Insomma ‘uno con i baffi’ che per giunta descrive ciò che ha vissuto realmente con sensazioni chiare e precise e le sai proprio mettere giù. Quel che tu scrivi mi pare sia come fotogrammi di una pellicola cinemascope con dei refrein avvolgenti dai contorni arrotondati che molto piacevolmente ti accompagnano per mano nell’immaginare le scene che descrivi con grande Maestria e capacità narrativa.
Ciò che è già stato scritto su di te va gran ben oltre il mio piccolo giudizio. A ciascuno il proprio campo; chi cura la propria zolla ed è felice di vederla verde nel vaso, chi il piccolo orto e chi la vastità di un grande campo dove son allineate con sapienza spazi ad essenze profumate, ad ortaggi, a frutti ed inoltre in fondo distese di ulivi secolari che affondono profonde radici da Madre Terra e tu sei proprio quello che sa far ciò.
Caro Giorgio, il piacere è tutto mio e poi proprio da te, un uomo che ha assaporato la mia stessa sabbia, uno che continua a far conoscere quanto è stato fatto nei tempi passati dai nostri vecchi. Sono sicuro che farai ancora molto parlare di te e di quella terra assolata. Le tue pagine coinvolgono e tendono a coinvolgere il lettore in un’atmosfera pacata e riflessiva. Bravo. Non mancherò di ordinare NUCY. …bel suol d’amore … addio
Giorgio Vindigni
E’ l’ultimo della trilogia; una narrativa degli ultimi dieci anni della nostra presenza a Tripoli. Pubblicato nel marzo 2019, a settembre aveva già raggiunto sei Premi letterari. Mi farebbe piacere una tua recensione su BLOG DEGLI AUTORI GIORGIO VINDIGNI dove potrai leggerne altre cui rispondo sempre. Grazie. Cordialità
Credo non ci siano abbastanza parole per descrivere le emozioni provate nel leggere i 3 romanzi della trilogia ” IL RITORNO, ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE E NUCY BEL SUOL D’AMORE ADDIO”.
Letti tutti e 3 tutti d’un fiato e ad ogni pagina frammenti di ricordi . ora vividi oppure sopiti, si sono materializzati prepotentemente nella mia mente. Sono tornata fanciulla , adolescente e ho rivissuto tante situazioni descritte nei 3 romanzi. Ringrazio vivamente l’autore per avermi fatto rivivere questi momenti meravigliosi. Non voglio aggiungere altro perché leggendo quasi tutti i commenti ho visto che altri hanno saputo molto meglio di me esprimere le loro sensazioni e mi associo a quanto hanno scritto. Di nuovo complimenti a Giorgio Vindigni.
Liliana
Cara Liliana, ti ringrazio per il tuo bellissimo commento che mi ha emozionato. Ho raggiunto lo scopo che mi ero prefissato nel raccontare quanto accaduto, e non sempre noto, nella storia contemporanea: ricordi di avvenimenti vissuti per molti e conoscenza di una parte storica italiana per altri. Ritengo valido il mio motto “DIFFONDERE LA CULTURA E’ COSA MERITEVOLE; ESSA NON HA CONFINI NE’ LIMITI DI SORTA. IMPADRONIRSENE GRATIFICA LO SPIRITO – Giorgio Vindigni” –
Giorgio Vindigni ha terminato brillantemente la trilogia di romanzi che ci raccontano la sua storia e la storia di tanti italiani. Dei primi due libri ho scritto la prefazione, mi sembra di averli letti ieri e ne conosco lo spessore e il valore didattico. Il terzo ho avuto la gioia di assaporarlo più tardi, ma ho ritrovato il nerbo narrativo che caratterizza Giorgio, lo stile neo – realista, la capacità di renderci partecipi delle vicende storiche con descrizioni dei fatti, dei luoghi e dei personaggi in modo visibile. E’ la sua Opera più sofferta. Ha richiesto una lunga gestazione, ma si è rivelata forse la più interessante. Senza nulla togliere a “Il ritorno” e ad “Aspirazioni di un’adolescente” , infatti “NucY” ci rende partecipi della conclusione della sua avventura libica e della fine del Secondo Conflitto. Un’Opera di alto valore letterario, che non presenta aspetti giornalisti, ma prettamente umani. Il neo – realismo in questo testo lascia il posto a una scrittura più distesa, più emozionale, che evoca gli scrittori nord – americani.
Mi congratulo con il mio Amico per il suo potenziale artistico e auguro all’intera trilogia la fortuna che merita.
Carissima Maria, ho avuto modo di conoscerti quale poetessa, scrittrice e critica letteraria, e apprezzare la tua grande preparazione in incontri, molti dei quali da te promossi. Le tue prefazioni sui miei primi due libri “IL RITORNO” (1922/1947) e “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” (1948/1959) oltre ad emozionarmi, mi hanno dato maggior entusiasmo a proseguire con il terzo “NUCY” (1959/1970), a completamento di una trilogia sulla “Presenza italiana in Libia” nell’ultimo decennio. Questa tua recensione su “NUCY” mi ha commosso e dato certezza di aver raggiunto lo scopo nell’aver interessato il lettore alla conoscenza in un pezzo di storia italiana.
Maria Teresa Di Tullio – Buon giorno, caro Giorgio, pensavo che leggere i tuoi libri non sarebbe stata cosa facile per me! Invece non è stato così! Grazie al tuo scrivere fluido, i tuoi bellissimi romanzi. con il racconto del tuo vissuto un Libia. mio hanno emozionato e portato a finire in tempi brevi la lettura. Sinceri complimenti per i meritati premi ricevuti, complimenti anche per l’ultimo bellissimo romanzo “NUCY”,. I miei più cari auguri per un prosieguo di grande successo! Buona giornata, un abbraccio, Maria Teresa
Cara Maria Teresa. un particolare ringraziamento a colei che ha letto i miei tre libri “IL RITORNO” – “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” – “NUCY… bel suol d’amore…addio”, una trilogia della presenza italiana in Libia. libri illustrati e multipremiati. Le sue espressioni sono un altro premio che soddisfa il mio spirito. Grazie Maria Teresa.
Caro Giorgio “Magno” quando avverrà la prossima pubblicazione? I primi due libri li ho letti tutto d’un fiato, mi hai fatto rivivere per la terza volta parte della nostra vita. Grazie infinite
Sono contento che la lettura dei primi due libri della trilogia “Presenza italiana in Libia” (1922/1970) ti abbiano fatto rivivere gli anni trascorsi a Tripoli (quale seconda nostra terra, come alcuni la definiscono). La storia non si può nè si deve dimenticare anzi è bene farla conoscere. Il terzo libro “NUCY…bel suol d’amore…addio” 1959/1970 è stato pubblicato nel marzo 2019 e nel mese di maggio ha già vinto un primo Premio letterario all’A.U.P.I. di Milano.
Grazie caro Luigi, diffondiamo la nostra cultura.
Con l’opera “IL RITORNO”, Giorgio Vindigni ci descrive un periodo importante del suo e del nostro passato, ma sono molti gli aspetti etici e morali investigati, e dunque esprimere un commento considerandola solamente una preziosa testimonianza sarebbe incompleto e riduttivo. In un momento storico come l’attuale, dove i principi e i valori stanno scomparendo lasciando il posto ad una società fondata sempre più sull’apparenza ed il culto del denaro potrebbe sembrare ingenuo, se non addirittura inutile, raccontare i sentimenti e le atmosfere di un’epoca in apparenza tanto lontana da noi. Oltretutto la paura di scoprire qualche verità scomoda o sottaciuta fino ad ora, esercita nella coscienza collettiva una sorta di ingiustificata renitenza a voler rileggere le pagine della nostra storia alla ricerca della realtà dei fatti. A mio parere non vi è nulla di più sbagliato, in quanto nella memoria delle generazioni che ci hanno preceduto e che prima di noi hanno sognato, lottato ed in molti casi sacrificato la propria vita è inciso il nostro DNA e dunque vi sono impresse le positività e le debolezze su cui dobbiamo lavorare oggi per superare le difficoltà che ci si presentano. E’ in questo che emerge l’importanza dell’opera di Giorgio Vindigni, nella sua capacità di riportare con passione. ma anche con grande rigore e imparzialità, il reale svolgimento degli eventi da lui vissuti in prima persona sottolineando così gli elementi distintivi che da sempre caratterizzano, nel bene e nel male, il popolo italiano. Ecco dunque emergere il coraggio, l’intraprendenza, l’ingegno, lo spirito di sacrificio e soprattutto l’umanità che da sempre ci contraddistinguono così come, aimè, la nostra cronica tendenza all’instabilità politica, la conseguente cattiva abitudine di governare sempre nell’ottica dell’emergenza, l’incapacità di opporsi con fermezza a quei nostri rappresentanti che non rispecchiano l’ideale di democrazia su cui ci fondiamo, la nostra inaffidabilità nelle alleanze internazionali e quella mancanza di unità che ci impedisce di esprimere le nostre potenzialità. Scorrendo le pagine de “IL RITORNO” si scoprono degli episodi poco conosciuti e si trova testimonianza di responsabilità ufficiali spesso volutamente omesse nei libri di testo e nei discorsi commemorativi. Si riaffacciano così le domande sulle tante vicende “politicamente scomode” archiviate in gran fretta e si fa luce su quegli scenari che sottolineano ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la crudeltà, la follia e l’egoismo che si celano dietro ogni guerra. Inoltrandosi in questo libro il lettore realizza, insomma, che la storia di quegli anni non è poi tanto diversa da quella dei nostri tempi. Certo, sono cambiati il contesto ed i protagonisti, ma il velo di ipocrisia che nasconde la verità dopo settanta anni appare ancora intatto, nessuna evoluzione sociale o culturale è riuscita ancora a strapparlo via. L’opera di Giorgio Vindigni non è quindi un romantico affaccio nel passato, ma un deciso, garbato invito agli Italiani di oggi e di domani a riallacciare i rapporti con la propria coscienza critica attraverso la conoscenza del passato e la riscoperta della loro identità. Un grazie di cuore, dunque, al nostro generoso autore ed un “in bocca al lupo” a tutti coloro che, raccogliendo il suo appello, lavoreranno per restituire alla nostra amata Patria la dignità e il prestigio che merita.
Caro Paolo, ho letto ed apprezzato quanto hai espresso su “IL RITORNO”, un libro scritto sulle emozioni personali vissute e sulle ricerche inerenti il periodo storico in cui si svolge la prima metà del ‘900. Il raffronto di quegli anni con il periodo attuale della storia italiana è di particolare apprezzamento e induce a meditare su quanto non è stato fatto per migliorare e incidere nei cuori, particolarmente dei giovani, quell’amore patrio che sembra in buona parte vanificato. Ruolo importante dovrebbe svolgere la scuola, che sembra insensibile a quanto accaduto nella storia contemporanea. Ho cercato di scuotere le coscienze contattando oltre venti scuole romane (scuole medie inferiori e superiori) senza avere risposte. Dobbiamo diffondere questa cultura per vedere “il ritorno” di quell’Italia democratica e forte l’ha vista risorgere dalla catastrofe causata dalla seconda guerra mondiale.
Complimenti per i tuoi interessanti libri. Una testimonianza importante per una storia che pochi conoscono affidata ai particolari della tua vita personale, alle cose piccole, quotidiane che tu Giorgio fai diventare immense preziose, inserite in una grande storia che diventa ancora più grande così piena dei sogni, dei dolori, dei sacrifici di un ragazzo. Una grande emozione! Grazie, Giuseppina Mondello
Ti ringrazio, cara. La presentazione del 07 novembre 2017 c/o la Sala della Banca Generali di Roma, sotto l’egida dell’IPLAC (Insieme per la Cultura), dei miei due libri “IL RITORNO” e “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” cui hai assistito, e stata di particolare interesse per l’ottima relazione degli amici, l’Attore e poeta Massimo Chiacchierarelli, il Filosofo e scrittore Franco Campeggiani, lo scrittore e opinionista Paolo Buzzacconi, la Poetessa, scrittrice e critica letteraria Prof.ssa Rosa Simonelli Macchi- L’intento è di diffondere la cultura sul ‘900 del nostro “Bel Paese”, per la “MEMORIA” degli anziani e l’ “APPRENDIMENTO” dei giovani. La Scuola non ha ancora capito, purtroppo, che non conoscendo gli orrori del passato non sanno essi regolarsi nel futuro. Leggendo i miei due romanzi si può apprendere, in maniera “soft” , quanto accaduto, senza traumi psicologici o strumentali. Un abbraccio, Giorgio
Carissimo, è stato un grande piacere incontrarti alla premiazione. Ti auguro ogni bene, che tu possa sempre continuare ad essere attivo ed ispirato. Sei la testimonianza vivente della storia dei nostri tempi, fa veramente tesoro della tua esperienza di vita per trasmettere valoptri, idee, conoscenze sul nostro essere umano e su come vivere ed operare, dando il meglio di se.
Cara Loreta, mi fa tanto piacere leggere quanto scrivi. Forse non merito tanto, faccio quello che posso per diffondere un poco di cultura su quanto accaduto che molti, in particolare i più giovani, non conoscono anche perché, purtroppo, la storia contemporanea non è contemplata nei programmi scolastici. Quali libri di lettura, o romanzi, essi potrebbero trasmettere ai giovani quelle notizie che hanno fatto soffrire il nostro popolo e non solo per fare in modo che questi fatti non accadano in futuro. “Historia magistra vitae”, il domani nin esiste ancora, ma il passato ci può essere da insegnamento per il futuro. Grazie cara. per la tua attenzione. Giorgio
MASSIMO CHIACCHIARARELLI PRESENTA IL LIBRO DI GIORGIO VINDIGNI
“IL RITORNO”
Narrativa storica 1922/1947
Per un critico prefare o presentare un libro non è mai piacevole e facile per una molteplicità di fattori che vanno dall’ipocrisia, se il critico non è onesto con se stesso e quindi, per compiacere l’autore, esprime un giudizio diverso da ciò che effettivamente l’opera ha suscitato in lui, alla vanità, se il critico è a conoscenza della megalomania dell’autore che esplicitamente ha chiesto un giudizio positivo quando non incensante, ovvero alla coerenza, quando il critico diviene novello Don Chisciotte, perché esprime liberamente il proprio pensiero ben sapendo che andare contro i desiderata dell’Autore e ferire la sua suscettibilità potrebbe renderselo odiato nemico per il resto dei propri giorni.
Chi mi conosce sa che appartengo a quest’ultima categoria, ma sa anche che le mie relazioni non contengono mai un giudizio definitivo sull’opera, ma mirano piuttosto ad esaminare il testo sia dal punto di vista letterario, dello stile, dei contenuti, che delle sensazioni che possa aver suscitato in me, in qualità di lettore attento.
Tutto questo preambolo mi è servito per farvi comprendere maggiormente quanto sia stato per me arduo presentarvi questa sera
“IL RITORNO” di GIORGIO VINDIGNI
trattandosi fondamentalmente di un romanzo con diversi colpi di scena, per cui diventa difficile parlarne, senza peraltro svelarne la trama e, quindi, togliere interesse al lettore.
C’è da precisare, innanzi tutto, che il romanzo ha il ritmo di un grafico da elettrocardiogramma, il cui tracciato va dal piattismo di alcune atmosfere dall’andamento lento e cupo, riscontrabile nei films di Ingmar Bergman, alle scosse ascensionali dei bioritmi che si alzano improvvisamente , quando alcuni accadimenti esplodono nella rugosa realtà del quotidiano.
I personaggi entrano improvvisamente in scena, a volte in flashback che danno l’impressione quasi che essi non appartengano alla storia narrata, ma poi si ripresentano in tutta la loro personalità, individualità, con i risvolti psicologici di entità facenti parte di una società dominata dalla violenza e da quella tragedia che fu la seconda guerra mondiale.
Non sono mai strumentalizzati ai fini della narrazione, ma colmi di spiritualità autonoma, di pathos e anche ethos, perfettamente integrati nelle scenografie rappresentate.
L’Autore recupera l’anima, lo spirito di una cultura popolare che ha raggiunto la sua massima espressività con Renato Fucini, Grazia Deledda e soprattutto Giovanni Verga, una cultura votata a portare sulla scena i personaggi non come prodotti storici e temporali, ma come coscienze per la ricerca dell’uomo nella sua interezza.
Vindigni dà dimensione ai suoi personaggi e questi si muovono in un complesso tra scena, retroscena e rappresentazione per ridefinire un destino, per intraprendere un viaggio non in termini strutturali ma metafisici, alla ricerca di una interpretazione antropologica (e quindi sociologica) della serenità, della conoscenza e della completezza interiore.
Lo scrittore ci parla di atti di fatti, di emozioni, di stati d’animo di un mondo che palpita nella realtà sociale ante e post bellica corredandoli di molte foto, con una serenità dialogica che scorre sui binari lucidi di una prosa, a volte poetica, la quale ci porge, a dolci sorsi e con una raffigurazione viva, schietta ed umana un microcosmo di personaggi che vivono nelle loro emozioni, nel loro modo di fare, nello scorrere lento del tempo, nelle loro ataviche usanze, nella loro schietta moralità e sagacia prettamente popolana.
Gli ambienti sono costruiti a regola d’arte per i personaggi, dove affiorano delle metafore, queste sono sempre suggestive; i personaggi non sono mai strumentalizzati ma colmi di spiritualità autonoma ed il lettore può così recuperare il senso ed il piacere della lettura.
Lo scrittore Fernand CUVELIER affermava: L’uomo un po’ alla volta si ricongiunge alla memoria” ed in effetti in Giorgio Vindigni emergono, dalla nebbia del passato, tessuti di ricordi d’infanzia, memorie di un mondo sommerso, sospeso tra passato e futuro, descritti con una capacità di ritratto che ti porta nelle pagine il sapore dell’aria, le atmosfere e gli ambienti del tempo, di cui l’Autore è maestro nel pennellare i tratti, quasi fosse un pittore macchiaiolo.
E’ uno scrittore d’istinto che ha tenuto d’occhio la sostanza per offrirci un più ampio respiro narrativo fatto di colori e di scorci paesaggistici, di fatti e misfatti storici legati al dolore di una società in disfacimento, di stati d’animo tratteggiati rapidamente, quasi per caso, ma potenti e indimenticabili.
L’ars narrandi è magistrale perché a volte usa anche chiavi simboliche per giungere all’essenza delle cose, alla dinamicità dei personaggi, alla rappresentazione palpabile degli avvenimenti.
Linguaggio immediato che fa affidamento alle cose, in un sapore intimo che si materializza in identità, sentimento, sensibilità, acuta osservazione, costante desiderio di fuga dalla abitudienarietà, di evasione dalle utopie, di metamorfosi delle illusioni che si riflettono nelle vicende narrate, generando un processo prodromico da cui nasce e si evolve la liricità del suo linguaggio, in un’espressione chiara, semplice, incisiva, ancorchè crudamente realistica.
A volte bastano poche righe, qualche parola appena, come la pennellata rapida che dà luce al quadro e tutto lo determina, per donarci una sequela di scenari che restano impressi nella memoria.
Il nostro Autore ha intrapreso un viaggio a ritroso nel tempo allo scopo di recuperare per sé e gli altri, attraverso frammenti di vita personale e spaccati di una società distrutta dalla dittatura e dalla guerra, quella morale che ricompatti questa società assolutamente egoistica e priva di ogni sintomo di coscienza umana, per cui l’uomo oggi si trova ad essere nudo di ogni atavico sentimentalismo, che pure aveva valorizzato e traslato nella propria esistenza.
Sono pagine, per noi più o meno della stessa generazione dell’Autore, un po’ malinconiche, ma mai retoriche, perché abbiamo vissuto quello spaccato sociale intensamente e insieme a Giorgio Vindigni, perché quegli anni difficili ci hanno forgiato uomini, perché quegli anni può ridarceli soltanto la memoria, dove rimarranno scolpiti fino alla fine dei nostri giorni.
Il tessuto letterario si snoda sulle ali della semplicità del linguaggio, il che rende oltremodo piacevole la lettura, se teniamo conto come oggi tanti pseudo scrittori facciano ricorso a linguaggi ai più incomprensibili, ma catalogati dalla “critica che conta” come “alti laboratori di ricerca”.
In questi miei bravi appunti di presentazione del libro
“IL RITORNO” di GIORGIO VINDIGNI,
come mia consuetudine, non ho parlato della trama del libro per non togliervi il piacere della lettura e della riscoperta di avvenimenti vissuti congiuntamente al protagonista, ma ho cercato di mettere in risalto quello che, a mio parere, può essere il pensiero e l’intento dell’Autore.
In pratica, per Giorgio Vindigni, è il ritorno che ci appartiene: si ritorna al passato per ritrovare le malinconie, gli affetti, le favole, gli umori, gli odori, i sacrifici, gli amori e i dolori di un tempo.
Si ritorna per fare del passato una componente del presente con proiezioni al futuro, perché la memoria altro non è che trasmissione e rielaborazione di significati.
Massimo Chiacchiararelli
Caro Massimo, sei stato grande. Hai toccato molti punti delicati dal punto di vista letterario che storico. Solo un maestro come te poteva realizzare un tale commento. Grazie per l’impegno che hai profuso e per la recitazione artistica da attore quale sei veramente.
F. CAMPEGIANI LEGGE: “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” DI G. VINDIGNI
Franco Campegiani,
collaboratore di Lèucade
Dopo “Il Ritorno”
“Aspirazioni di un adolescente”
nuovo romanzo storico di Giorgio Vindigni
In “Aspirazioni di un adolescente” (Helicon editrice), Giorgio Vindigni continua il racconto della sua vita iniziato con l’opera precedente, intitolata “Il ritorno”. Anche questo è un romanzo autobiografico cucito sullo sfondo di vicende internazionali di fondamentale importanza per la storia del XX secolo. Non si pensi pertanto al diario di intonazione intimistica. Non lo consente anzitutto l’uso della terza persona, anziché della prima, come è consuetudine in quella forma letteraria. Qui l’autore, Vindigni, prende le distanze da Giorgio, che è lui stesso, il protagonista dell’azione narrata.
C’è poi da considerare l’uso del tempo passato, anziché di quello presente, come accade nel diario generalmente scritto a caldo. E, si sa, il tempo passato, il tempo del ricordo, differisce l’azione narrativa collocandola all’indietro nel tempo, il che consente di osservare le vicende narrate da una certa distanza, di filtrarle dunque, senza adulterarle, rendendo in qualche modo oggettivo il racconto e stemperandone il calore intimistico. Dove si collocano i fatti? Geograficamente in due Paesi distinti, la Libia e l’Italia; storicamente in quel lasso di tempo che va dalla fine degli anni Trenta alla fine dei Cinquanta, il ventennio cruciale del XX° secolo.
E’ il periodo postbellico, caratterizzato dal dilagare della società di massa dei tempi attuali, con la fine della società contadina, da un lato, e la ricostruzione civile dall’altro. Il periodo che vede la nascita, ma anche la graduale relativizzazione, di tutte le ideologie: il marxismo proletario da un lato e il cattolicesimo borghese dall’altro (Camillo e don Peppone, per intenderci), sullo sfondo di quel sogno americano che viepiù viene scivolando verso l’omologazione e il dominio tecnologico. Gli scenari descritti da Vindigni non riguardano tuttavia il mondo occidentale in senso stretto, ma vi si affiancano e lo completano, con l’affresco di quelle vicende del mondo arabo che sono parallele ad esso e con esso si fondono in un unico quadro storico.
Si è parlato giustamente di Neorealismo a proposito dello stile di Giorgio Vindigni, sostanzialmente veristico e filmico, caratterizzato da vivacità, colore e presa diretta sulla vita pubblica. Lo ha fatto in modo specifico Carmelo Consoli, parlando del precedente lavoro dell’autore, “Il Ritorno”, e sottolineandone l’umanità, la schiettezza e il vigore narrativo, con quelle “ampie aperture epocali politiche, sociali, storiche, e quindi antropologiche, ad ampio respiro, tali da farlo risultare un grande affresco della nostra storia del ‘900 pre e post bellica un po’ come lo sono stati in campo cinematografico i film del neo realismo italiano da Fellini a Visconti ad Antonioni”.
C’è da specificare che il neorealismo di Vindigni non si esprime nei termini di una rappresentazione della vita popolare e del mondo operaio, ma è piuttosto una zumata sulla ricostruzione civile, sull’industrializzazione e sul cosiddetto miracolo economico che allo stesso titolo ha caratterizzato la storia di quegli anni. Non a caso il giovane Giorgio, dopo mille peripezie (fra cui quella di una vocazione sacerdotale incompiuta) si dedicherà a studi di indirizzo tecnico commerciale che lo introdurranno nel mondo delle banche. Tant’è che nel 1987, lui oramai cinquantenne, darà addirittura alle stampe un testo, “Bancaria”, con il proposito di divulgare la tecnica del funzionamento di banca.
Sta qui il realismo, o il verismo, della scrittura vindignana, una scrittura che nasce dalla vita e che ha fede nella vita. Orizzonte, questo, che tiene lontano l’autore da ogni tentazione estetizzante o retorica, da ogni risucchio nell’orbita decadentistica, che pure attrae tanta letteratura dei nostri tempi. L’autore racconta in queste pagine i primi ventuno anni della propria esistenza, particolarmente avventurosi, con le incertezze sulla strada da percorrere, con i repentini cambi di rotta e di intenzioni, con i continui viaggi tra l’Italia e l’Africa, con i primi contatti con l’altro sesso, eccetera. Stupendo è quanto scrive nell’introduzione, a proposito di questo aprirsi del giovane alla vita.
Egli scrive: “L’adolescenza è l’età più bella… Usciti dal periodo della pubertà, ci si lancia verso nuove esperienze. Tutto è novità; la famiglia, la scuola, i compagni e gli amici. Un fiore che sboccia, apre lentamente i suoi petali; assaporando l’aria fresca del mattino, si schiude al sole che sorge e si scalda ai raggi che lo inondano dandogli colore e luminosità… Il fanciullo cresce, apprende, imita, scopre un mondo nuovo di cui si sente partecipe… Indaga su coloro che attirano la sua attenzione, sulle professioni da essi svolte… Si confronta con i suoi coetanei e comincia a progettare cosa mai farà da grande… A corredo della sua formazione concorrono tutti quegli avvenimenti che lo circondano, e fanno da cornice alla sua esistenza, durante il percorso degli anni del suo sviluppo”.
Il racconto inizia con Giorgio poco più che bambino, quando insieme alla mamma Emma raggiunge il padre Antonio, trapiantato a Tripoli durante il periodo bellico. Madre e figlio vengono dalla Sicilia, da Modica per l’esattezza, in provincia di Ragusa, dopo la morte della sorella di Giorgio, Assunta, avvenuta in seguito ai bombardamenti inglesi. Questa fase iniziale della sua vita è davvero triste, ed è oltretutto aggravata da un incidente occorsogli per essere investito, mentre torna insieme al padre, in tandem, in bicicletta, da un camion di soldati inglesi che fuggono dai musulmani insorti contro gli invasori. L’incidente rappresenta l’inizio di un vero e proprio calvario per il bimbo, costretto a subire ripetuti interventi chirurgici alla gamba, con lunghissimi ricoveri ospedalieri.
Bersagliato da tante sofferenze, il ragazzo è stimolato a crescere rapidamente, maturando un carattere forte e antagonista, ricco di determinazione e di sana voglia di riscatto (non di rivalsa, ma di riscatto). In tutto quel tempo, egli medita profondamente su quanto potrà fare da grande, vagliando varie opportunità, a partire dalla sua spiccata attitudine canora, che gli procura notevoli soddisfazioni pubbliche. La scelta che sembra prevalere, anche se poi abbandonata, è tuttavia quella clericale, come già detto, spinto dal desiderio di aiutare la gioventù e di educarla, sull’esempio di Don Bosco e dei padri salesiani. Si iscrive pertanto nelle scuole salesiane di Napoli, in Aspirantato, dolorosamente consapevole di doversi allontanare dalla famiglia e soprattutto dall’autoritario, ma amatissimo padre, figura quasi miticizzata.
“Aspirazioni di un adolescente” diviene così il racconto di una saga familiare le cui vicissitudini s’intrecciano sullo sfondo della storia generale del Novecento, riguardante in particolare i travagliati rapporti del mondo occidentale con il mondo arabo, in piena trasformazione entrambi. L’autore, narrando le proprie vicende, ritesse abilmente la trama delle difficili relazioni tra i due mondi, che, nate in quel tempo, o forse peggiorate in quel tempo, sembrano destinate a restare irrisolte, e fino ad oggi lo sono, deteriorandosi. Particolarmente illuminanti sono gli spaccati di vita politica e sociale che sapientemente egli innesta nell’esposizione romanzata delle proprie vicende e di quelle della sua famiglia. Ricapitoliamole.
Prima della Seconda Guerra Mondiale, la Libia è colonia dell’Impero Italiano, fin quando le nostre truppe non sono scacciate dagli Alleati nel ’43. Da allora la Libia viene dominata dalla Francia e dal Regno Unito, fino a quando l’ONU stabilisce che la Libia deve diventare indipendente con regime monarchico, offrendone la corona a Idris Senussi, Califfo di Cirenaica e Tripolitania. Siamo nel ’52, e poco dopo il Paese aderisce alla Lega Araba. A quel punto gli scenari si ampliano su tutto il mondo arabo: dall’ascesa di Nasser in Egitto, nel ’54, fino all’inizio di quelle ostilità con Israele e con l’Occidente, che non verranno mai più risolte e si complicheranno fino ai nostri giorni. E’ ancora lontano l’avvento del colonnello Gheddafi, che pure viene nominato nel libro, il quale nel ’69 abbatterà la monarchia di Idris per imporre in Libia il suo regime.
Interessanti sono, oltre agli aspetti storici, gli aspetti antropologici del testo, dai rapporti frizzanti e vivaci con l’altro sesso ai contrasti generazionali, in particolar modo con l’autoritarismo paterno. E qui mi piace estrapolare un passo particolarmente emblematico: “Non fu facile per Giorgio ottenere dal padre il permesso per la notte di Capodanno a casa di Rosy, una compagna di studi che abitava nei pressi di casa sua, insieme con altri amici della stessa classe. Non lo avesse mai chiesto. Antonio reagì dicendo che egli non era un pipistrello e che non sarebbe dovuto stare fuori casa oltre le ventidue. Alle insistenze di Giorgio, il padre alzò il braccio per imprimere forza al suo discorso.
Il giovane, spaventato, gli afferrò il polso e gli suggerì di non usare quel metodo che riteneva sbagliato. Lo fissò negli occhi e salì di sopra, mentre Giorgio usciva per recarsi alla festa di fine anno; non voleva sfigurare con gli amici, a vent’anni si sentiva abbastanza responsabile delle sue azioni. Il padre non aveva forse tutti i torti; di notte avrebbe potuto imbattersi in qualche indigeno male intenzionato, il che non era cosa rara. Egli poté riprendere il dialogo con il padre non prima di una settimana; quest’ultimo non si sarebbe aspettata una tale reazione da parte del figlio che tanto stimava per la sua educazione e bontà d’animo.
I contrasti con il padre erano del tutto accademici; s’incentravano sugli avvenimenti riportati dalla radio italiana o da qualche giornale che giungeva dall’Italia, sempre il giorno dopo la sua uscita, per via aerea. Era il 1958 quando la radio trasmetteva notizie riguardanti un non lontano futuro in cui l’uomo avrebbe messo piede sulla luna; avvenimento da lui definito pazzesco ed irraggiungibile, ma Giorgio lo contraddiceva essendo più speranzoso nella scienza”. Ci troviamo alla fine di un’epoca e all’inizio di un’altra. Tutto ciò avrebbe condotto alla costituzione di quella vita giovanile autonoma e – fatto nuovo nella storia – distaccata da quella degli adulti, destinata a produrre tra non molto i movimenti giovanili degli anni Sessanta.
Per concludere, la scrittura di Vindigni è minuziosa e limpida, con quella tramatura ricchissima di episodi privati e pubblici che ne fanno un grande affresco corale, ricco di umanità e di umori etici. Mirabile il paziente lavoro di ricostruzione memoriale, nonché l’acribia della ricerca storica. Un’ampia e documenta rappresentazione retrospettiva dell’età giovanile dell’autore, innestata nelle fasi conclusive di una cultura popolare che andava immolandosi sull’altare della grigia società di massa dei tempi attuali e che di lì a poco avrebbe prodotto la “società liquida” di cui parlerà Bauman, con i feticci del Postmoderno e le conquiste dell’era tecnologica. Ma di questo è prematuro parlare e immagino che sarà argomento di un prossimo libro dello scrittore. Lo aspettiamo con grande curiosità.
Franco Campegiani
F. CAMPEGIANI LEGGE: “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” DI G. VINDIGNI
Franco Campegiani,
collaboratore di Lèucade
Dopo “Il Ritorno”
“Aspirazioni di un adolescente”
nuovo romanzo storico di Giorgio Vindigni
In “Aspirazioni di un adolescente” (Helicon editrice), Giorgio Vindigni continua il racconto della sua vita iniziato con l’opera precedente, intitolata “Il ritorno”. Anche questo è un romanzo autobiografico cucito sullo sfondo di vicende internazionali di fondamentale importanza per la storia del XX secolo. Non si pensi pertanto al diario di intonazione intimistica. Non lo consente anzitutto l’uso della terza persona, anziché della prima, come è consuetudine in quella forma letteraria. Qui l’autore, Vindigni, prende le distanze da Giorgio, che è lui stesso, il protagonista dell’azione narrata.
C’è poi da considerare l’uso del tempo passato, anziché di quello presente, come accade nel diario generalmente scritto a caldo. E, si sa, il tempo passato, il tempo del ricordo, differisce l’azione narrativa collocandola all’indietro nel tempo, il che consente di osservare le vicende narrate da una certa distanza, di filtrarle dunque, senza adulterarle, rendendo in qualche modo oggettivo il racconto e stemperandone il calore intimistico. Dove si collocano i fatti? Geograficamente in due Paesi distinti, la Libia e l’Italia; storicamente in quel lasso di tempo che va dalla fine degli anni Trenta alla fine dei Cinquanta, il ventennio cruciale del XX° secolo.
E’ il periodo postbellico, caratterizzato dal dilagare della società di massa dei tempi attuali, con la fine della società contadina, da un lato, e la ricostruzione civile dall’altro. Il periodo che vede la nascita, ma anche la graduale relativizzazione, di tutte le ideologie: il marxismo proletario da un lato e il cattolicesimo borghese dall’altro (Camillo e don Peppone, per intenderci), sullo sfondo di quel sogno americano che viepiù viene scivolando verso l’omologazione e il dominio tecnologico. Gli scenari descritti da Vindigni non riguardano tuttavia il mondo occidentale in senso stretto, ma vi si affiancano e lo completano, con l’affresco di quelle vicende del mondo arabo che sono parallele ad esso e con esso si fondono in un unico quadro storico.
Si è parlato giustamente di Neorealismo a proposito dello stile di Giorgio Vindigni, sostanzialmente veristico e filmico, caratterizzato da vivacità, colore e presa diretta sulla vita pubblica. Lo ha fatto in modo specifico Carmelo Consoli, parlando del precedente lavoro dell’autore, “Il Ritorno”, e sottolineandone l’umanità, la schiettezza e il vigore narrativo, con quelle “ampie aperture epocali politiche, sociali, storiche, e quindi antropologiche, ad ampio respiro, tali da farlo risultare un grande affresco della nostra storia del ‘900 pre e post bellica un po’ come lo sono stati in campo cinematografico i film del neo realismo italiano da Fellini a Visconti ad Antonioni”.
C’è da specificare che il neorealismo di Vindigni non si esprime nei termini di una rappresentazione della vita popolare e del mondo operaio, ma è piuttosto una zumata sulla ricostruzione civile, sull’industrializzazione e sul cosiddetto miracolo economico che allo stesso titolo ha caratterizzato la storia di quegli anni. Non a caso il giovane Giorgio, dopo mille peripezie (fra cui quella di una vocazione sacerdotale incompiuta) si dedicherà a studi di indirizzo tecnico commerciale che lo introdurranno nel mondo delle banche. Tant’è che nel 1987, lui oramai cinquantenne, darà addirittura alle stampe un testo, “Bancaria”, con il proposito di divulgare la tecnica del funzionamento di banca.
Sta qui il realismo, o il verismo, della scrittura vindignana, una scrittura che nasce dalla vita e che ha fede nella vita. Orizzonte, questo, che tiene lontano l’autore da ogni tentazione estetizzante o retorica, da ogni risucchio nell’orbita decadentistica, che pure attrae tanta letteratura dei nostri tempi. L’autore racconta in queste pagine i primi ventuno anni della propria esistenza, particolarmente avventurosi, con le incertezze sulla strada da percorrere, con i repentini cambi di rotta e di intenzioni, con i continui viaggi tra l’Italia e l’Africa, con i primi contatti con l’altro sesso, eccetera. Stupendo è quanto scrive nell’introduzione, a proposito di questo aprirsi del giovane alla vita.
Egli scrive: “L’adolescenza è l’età più bella… Usciti dal periodo della pubertà, ci si lancia verso nuove esperienze. Tutto è novità; la famiglia, la scuola, i compagni e gli amici. Un fiore che sboccia, apre lentamente i suoi petali; assaporando l’aria fresca del mattino, si schiude al sole che sorge e si scalda ai raggi che lo inondano dandogli colore e luminosità… Il fanciullo cresce, apprende, imita, scopre un mondo nuovo di cui si sente partecipe… Indaga su coloro che attirano la sua attenzione, sulle professioni da essi svolte… Si confronta con i suoi coetanei e comincia a progettare cosa mai farà da grande… A corredo della sua formazione concorrono tutti quegli avvenimenti che lo circondano, e fanno da cornice alla sua esistenza, durante il percorso degli anni del suo sviluppo”.
Il racconto inizia con Giorgio poco più che bambino, quando insieme alla mamma Emma raggiunge il padre Antonio, trapiantato a Tripoli durante il periodo bellico. Madre e figlio vengono dalla Sicilia, da Modica per l’esattezza, in provincia di Ragusa, dopo la morte della sorella di Giorgio, Assunta, avvenuta in seguito ai bombardamenti inglesi. Questa fase iniziale della sua vita è davvero triste, ed è oltretutto aggravata da un incidente occorsogli per essere investito, mentre torna insieme al padre, in tandem, in bicicletta, da un camion di soldati inglesi che fuggono dai musulmani insorti contro gli invasori. L’incidente rappresenta l’inizio di un vero e proprio calvario per il bimbo, costretto a subire ripetuti interventi chirurgici alla gamba, con lunghissimi ricoveri ospedalieri.
Bersagliato da tante sofferenze, il ragazzo è stimolato a crescere rapidamente, maturando un carattere forte e antagonista, ricco di determinazione e di sana voglia di riscatto (non di rivalsa, ma di riscatto). In tutto quel tempo, egli medita profondamente su quanto potrà fare da grande, vagliando varie opportunità, a partire dalla sua spiccata attitudine canora, che gli procura notevoli soddisfazioni pubbliche. La scelta che sembra prevalere, anche se poi abbandonata, è tuttavia quella clericale, come già detto, spinto dal desiderio di aiutare la gioventù e di educarla, sull’esempio di Don Bosco e dei padri salesiani. Si iscrive pertanto nelle scuole salesiane di Napoli, in Aspirantato, dolorosamente consapevole di doversi allontanare dalla famiglia e soprattutto dall’autoritario, ma amatissimo padre, figura quasi miticizzata.
“Aspirazioni di un adolescente” diviene così il racconto di una saga familiare le cui vicissitudini s’intrecciano sullo sfondo della storia generale del Novecento, riguardante in particolare i travagliati rapporti del mondo occidentale con il mondo arabo, in piena trasformazione entrambi. L’autore, narrando le proprie vicende, ritesse abilmente la trama delle difficili relazioni tra i due mondi, che, nate in quel tempo, o forse peggiorate in quel tempo, sembrano destinate a restare irrisolte, e fino ad oggi lo sono, deteriorandosi. Particolarmente illuminanti sono gli spaccati di vita politica e sociale che sapientemente egli innesta nell’esposizione romanzata delle proprie vicende e di quelle della sua famiglia. Ricapitoliamole.
Prima della Seconda Guerra Mondiale, la Libia è colonia dell’Impero Italiano, fin quando le nostre truppe non sono scacciate dagli Alleati nel ’43. Da allora la Libia viene dominata dalla Francia e dal Regno Unito, fino a quando l’ONU stabilisce che la Libia deve diventare indipendente con regime monarchico, offrendone la corona a Idris Senussi, Califfo di Cirenaica e Tripolitania. Siamo nel ’52, e poco dopo il Paese aderisce alla Lega Araba. A quel punto gli scenari si ampliano su tutto il mondo arabo: dall’ascesa di Nasser in Egitto, nel ’54, fino all’inizio di quelle ostilità con Israele e con l’Occidente, che non verranno mai più risolte e si complicheranno fino ai nostri giorni. E’ ancora lontano l’avvento del colonnello Gheddafi, che pure viene nominato nel libro, il quale nel ’69 abbatterà la monarchia di Idris per imporre in Libia il suo regime.
Interessanti sono, oltre agli aspetti storici, gli aspetti antropologici del testo, dai rapporti frizzanti e vivaci con l’altro sesso ai contrasti generazionali, in particolar modo con l’autoritarismo paterno. E qui mi piace estrapolare un passo particolarmente emblematico: “Non fu facile per Giorgio ottenere dal padre il permesso per la notte di Capodanno a casa di Rosy, una compagna di studi che abitava nei pressi di casa sua, insieme con altri amici della stessa classe. Non lo avesse mai chiesto. Antonio reagì dicendo che egli non era un pipistrello e che non sarebbe dovuto stare fuori casa oltre le ventidue. Alle insistenze di Giorgio, il padre alzò il braccio per imprimere forza al suo discorso.
Il giovane, spaventato, gli afferrò il polso e gli suggerì di non usare quel metodo che riteneva sbagliato. Lo fissò negli occhi e salì di sopra, mentre Giorgio usciva per recarsi alla festa di fine anno; non voleva sfigurare con gli amici, a vent’anni si sentiva abbastanza responsabile delle sue azioni. Il padre non aveva forse tutti i torti; di notte avrebbe potuto imbattersi in qualche indigeno male intenzionato, il che non era cosa rara. Egli poté riprendere il dialogo con il padre non prima di una settimana; quest’ultimo non si sarebbe aspettata una tale reazione da parte del figlio che tanto stimava per la sua educazione e bontà d’animo.
I contrasti con il padre erano del tutto accademici; s’incentravano sugli avvenimenti riportati dalla radio italiana o da qualche giornale che giungeva dall’Italia, sempre il giorno dopo la sua uscita, per via aerea. Era il 1958 quando la radio trasmetteva notizie riguardanti un non lontano futuro in cui l’uomo avrebbe messo piede sulla luna; avvenimento da lui definito pazzesco ed irraggiungibile, ma Giorgio lo contraddiceva essendo più speranzoso nella scienza”. Ci troviamo alla fine di un’epoca e all’inizio di un’altra. Tutto ciò avrebbe condotto alla costituzione di quella vita giovanile autonoma e – fatto nuovo nella storia – distaccata da quella degli adulti, destinata a produrre tra non molto i movimenti giovanili degli anni Sessanta.
Per concludere, la scrittura di Vindigni è minuziosa e limpida, con quella tramatura ricchissima di episodi privati e pubblici che ne fanno un grande affresco corale, ricco di umanità e di umori etici. Mirabile il paziente lavoro di ricostruzione memoriale, nonché l’acribia della ricerca storica. Un’ampia e documenta rappresentazione retrospettiva dell’età giovanile dell’autore, innestata nelle fasi conclusive di una cultura popolare che andava immolandosi sull’altare della grigia società di massa dei tempi attuali e che di lì a poco avrebbe prodotto la “società liquida” di cui parlerà Bauman, con i feticci del Postmoderno e le conquiste dell’era tecnologica. Ma di questo è prematuro parlare e immagino che sarà argomento di un prossimo libro dello scrittore. Lo aspettiamo con grande curiosità.
Franco Campegiani
Caro Franco, il tuo commento e le tue descrizioni sono di particolare importanza e in sintonia con quanto espresso nel romanzo. Desidero ringraziarti per la tua preziosa collaborazione nel presentare il mio libro di narrativa storica “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” 1948/1959 -definito: “Un libro meraviglioso unico nel suo genere”. Il libro, infatti, spazia fra argomenti storici, turistici, letterari, religiosi. GRAZIE, Giorgio
Giorgio Vindigni nel suo romanzo d’esordio “Il ritorno” si presenta ai lettori con una delle forme espressive meno diffuse nella letteratura italiana, ovvero la saga, intesa come ampio racconto della storia di una famiglia.
Il testo è autobiografico e l’Autore insiste nell’asserire che ama attenersi al vero storico, evitando la narrazione romanzata o fantastica. In realtà scorrendo le pagine della sua poderosa Opera si coglie la padronanza dell’ ars narrandi e la capacità di attingere al laboratorio neo-realista, rinnovando gli schemi oggettivi tradizionali, curando con attenzione la coralità dei personaggi, la suggestione dei contesti, le tensioni emozionali dei protagonisti e delle figure che si avvicendano nella loro storia.
A mio avviso, seppur inconsapevolmente, Giorgio Vindigni non ha uno stile chirurgico, ma dipinge il vero distillando linfa dall’intenso universo dell’affettività.
L’Autore inserisce con sapienza le vicende del proprio nucleo familiare nell’epica narrazione della
Seconda Guerra Mondiale. Si attiene, con rigore, al carattere delle saghe nordiche, analizzando le cause e gli effetti storici del conflitto e inserendo nella nudità dell’analisi storiografica la ricchezza emozionale delle vicende dei protagonisti, costretti a emigrare da Tripoli nella città di Modica, tra i monti Iblei, in Sicilia.
Le sequenze dei corpi narrativi attribuiscono al romanzo un intreccio complesso e affascinante di retrospezioni e di anticipazioni. L’itinerario della saga scorre secondo la logica del tempo misto, che prevede la capacità dell’Autore di dedicarsi alla focalizzazione dei protagonisti e dei personaggi di contorno, ai loro sentimenti, alle loro rassegnazioni e alle loro lotte.
“Il ritorno”, epopea di un lungo periodo della nostra storia recente e di una generazione, ha senz’altro valore didattico e trascina nel fiume in piena di una vicenda, simbolo d’infinite altre vicende, d’amore e di dolore familiare.
Cara Maria, ti ammiro e stimo per la tua preparazione letteraria; sei poetessa e scrittrice di livello molto nota. Ti ringrazio per il tuo commento che rispecchia il mio pensiero nel raccontare quanto ho vissuto.
“IL RITORNO”
di Giorgio Vindigni
Il romanzo è costruito sul filo della memoria e recupera non solo il vissuto dell’autore, ma di tutta una generazione, attraverso la descrizione della dimensione antropologica della plaga sud-orientale dell’isola in un romanzo storico particolare, quello dell’avvento del fascismo, del suo tentativo di costituzione di un impero coloniale in Africa e della fine di questo “sogno”.
La narrazione è sintatticamente corretta, il linguaggio vario e puntuale non solo nella descrizione cronologica dei fatti e degli avvenimenti, ma anche per le caratteristiche di lettura introspettiva di emozioni, sentimenti, stati d’animo.
La voce narrante orienta sapientemente il lettore nella scoperta del vissuto del protagonista, anzi dei co-protagonisti, nell’ambito di una sorta di saga familiare drammatica.
I personaggi sono ben costruiti, gli ambienti e le cose hanno la loro dimensione di realtà proprio per la intenzionalità dell’autore di voler scrivere un “romanzo storico”.
Nel romanzo sembra prevalere, infatti, assieme alla storia della famiglia Vinci, anche la storia vera, la Histoire evenimentale, come direbbero gli storiografi francesi: cioè, cronologia e cronografia di fatti e personaggi che hanno deciso delle sorti di popoli, nazioni, del mondo intero (ciò, se si pensa soltanto che nel frangente temporale in cui accadono questi avvenimenti di saga familiare, fascismo, nazismo, franchismo, uso delle bombe su popolazioni inermi, ed altro ancora, segnano in modo indelebile la storia e la cultura politico-sociale dell’umanità).
Il quarto capitolo intitolato “il dolore” e il quinto “fine di un incubo”, costituiscono il perno attorno a cui gira tutta la storia e, se vogliamo, parte del destino di quella famiglia. Desiderio dell’autore è che questi capitoli vengano letti con scrupoloso raccoglimento e rispetto per ciò che esprimono. Tale attenzione sembra far eco alle parole che Virgilio, nel secondo canto dell’Eneide, mette in bocca ad Enea, che sollecitato dalla regina Didone, rievoca i tragici eventi di Troia: ”Infandum, regina, iubes renovare dolorem”- O regina, tu mi chiedi di rinnovare un terribile dolore. E poi: “quamquam animus meminisse horret, luctuque refugit, incipiam” Benché l’animo rifugga sbigottito dal dolore e la memoria tremi, tuttavia comincerò….Il dolore espresso va rispettato in quanto nasconde pudore e riservatezza che di solito accompagna questi avvenimenti, queste emozioni.
E’ un libro nel quale vive la religiosità nell’evocare l’aiuto divino nelle avversità; il ricordo dei luoghi comuni, le fasi lunari e la loro influenza su fatti, persone e cose (astrologia, pregiudizi, sentir comune, spiegazione popolare); l’elenco delle tradizioni come il “Sangiovanni”, Pietro col fischietto, il corredo sponsale, la preghiera per il temporale, i mustazzola, u strattu, le sanguisughe, il pane e pasta fatti in casa con lo scaniaturi, la preghiera per il pane “l’angilu passa e a razzia ci lassa, l’angilu passau e a razzia ci lassau”, u tumazzu (il formaggio) e la ricotta, i scacci, calacausi e simienza, i piretta,, u lignu ansuatu, i pignatieddi, i laurunci, i Sangiuggiari e Sanpitrari, u truppiettu, a strina (bon capu r’annu e bon capu matina, rapitimi a bussa e fatimi a strina) la strenna che i bambini chiedevano per capod’anno, in pochi soldini; i giochi come la fossetta, il truppiettu (trottola), il passo-volante, ecc……
Professor Piergiorgio Barone
Quanto ha scritto il Prof. Barone mi rende felice; ha carpito il mio vero pensiero e la mia intenzione di rendere comprensibile a tutti i livelli, quanto accaduto, in particolare nella zona Iblea, con particolari storici, usi e costumi molti dei quali ancor oggi si ripetono. Grazie Professore per il suo autorevole giudizio. Lo ammiro e stimo per lo slancio che mi ha infuso, fin dall’inizio, nella composizione di questa mia opera.
E’ stato un grande piacere incontrarti alla premiazione del tuo libro. Ti auguro ogni bene, che tu possa sempre continuare ad essere attivo ed ispirato. Sei la testimonianza vivente della storia dei nostri tempi, fa veramente tesoro della tua esperienza di vita per trasmettere valorui, idee, conoscenze sul nostro essere umano e su come vivere ed operare, dando il meglio di sé. Auguri.
Cara Loreta, ti ringrazio per le tue belle espressioni e per l’incoraggiamento a continuare a raccontare la storia vissuta, per tenere viva “la memoria” su quanto, purtroppo, è accaduto perché la sofferenza serva da stimolo per percorrere un lungo periodo di pace. “IL RITORNO” 1922/1947 – ha già riscosso 19 Premi letterari (08.2015) di cui 2 all’Estero (Lugano – Parigi) – Il seguito “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” 1948/1959 – 9 Premi in un anno. Il terzo, a compimenti della trilogia, 1959/1970, è in fase di lavorazione.
Accolgo con piacere la tua esortazione e ti ringrazio di cuore.
Carissimo Giorgio, alcuni minuti fa ho finito di leggere “IL RITORNO”. Anche io, pur non essendo Dott.ssa, Professore, ti faccio le mie congratulazioni; il tuo libro è un capolavoro letterario. Leggendo mi sono trovata coinvolta nelle vicende di quel “bedduzzo” di nome Gigino. A Tripoli ho imparato il dialetto siciliano e quindi non puoi immagina il piacere che mi ha fatto leggere le frasi da te accennate e, soprattutto, alcune usanze. Il momento più emozionante per me è stato quando tu hai accennato al periodo in cui i nostri soldati, durante la guerra, andarono dispersi. La mia mamma ha perso in quel periodo due giovani fratelli e non si è mai saputa la loro sorte; si pensava fossero finiti in Siberia. Non vedo l’ora di iniziare il secondo libro “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE”. Grazie del tuo dono e cerco di fare pubblicità fa i miei amici italiani. Ti abbraccio caramente.
Cara Lilly, mi fai tornare indietro al tempo della vita studentesca. Sei stata sempre una grande simpaticona e quanto mi scrivi mi fa tantissimo piacere. La mia grande soddisfazione è quando, come in questo caso, riesco a suscitare tanti sentimenti e ricordi che ci coinvolgono. Grazie cara.
Caro Giorgio Vindigni.
Leggendo “Il Ritorno”, sembra quasi aver vissuto le vicende del Secolo scorso dell’amata città di Modica, il fascino della vita quotidiana di un fanciullo siciliano che si rapporta in quel clima mediterraneo quasi più esotico della Libia stessa. Dentro la cornice della seconda guerra mondiale, il giovane protagonista affronta le sue prime esperienze a volte allegre anche buffe ma a volte fortemente commoventi, come l’agonia di una morte. In modo armonioso e dettagliato il romanzo ci distrae e ci insegna parlandoci della quotidianità e delle vicende della famiglia in questione ma allo stesso tempo si alternano le informazioni sul quadro storico italiano ed europeo, esse sono tramandate in modo esemplarmente semplice e lineare, dando un’illustrazione concreta della situazione in cui volgeva la Nazione italiana e il suo popolo coinvolto suo malgrado nel secondo conflitto mondiale. Il decorso degli eventi ha come oggetto le vicende di una famiglia di profughi che vive le illusioni e la confusione della guerra in Libia a seguito dell’avanzata degli alleati. Gli isolani poco o per niente sentivano loro quella guerra così da facilitare in meno di un mese l’avanzata anglo-americana in Sicilia ma anche lo sfruttamento delle popolazioni libiche espropriate dei loro terreni. Allo Stato fascista poco interessava lo stravolgimento di un Paese africano, il fine era creare una colonia di popolamento considerandola un investimento a favore dell’Italia ma la storia dovrebbe insegnare che ciò che prendi con la forza poi viene tolto, il ritorno storico lo dimostra ma tutt’oggi dagli aggiornamenti di cronaca nel mediterraneo che riempiono i nostri quotidiani possiamo constatare che le vicende picaresche dei profughi italiani non abbiano insegnato molto. Penso che la lettura del romanzo “Il Ritorno”possa far rivivere le vicende passate ed emozionare il lettore con l’analisi antropologica isolana che vive nel racconto stesso. Il romanzo trova riscontro anche nel mio saggio storico “Libia 1911- 2011. Gli italiani da colonizzatori a profughi, (edito dalla Kappa Vu) penso che i due testi vivano uno stretto parallelismo, analizzano sì gli eventi da due diversi profili il primo narrativo e l’altro storico ma dentro la stessa cornice nutrita dal medesimo amore per l’Isola bagnata dal Mediterraneo.
Dott. Luca Marchi
Il tuo commento è molto importante perché ripercorri con abilità quanto hai letto, facendo rivivere la storia vissuta con le sue glorie e i suoi dolori. Grande merito hai per il tuo libro “Libia 1911-2011” con una folta raccolta di leggi, decreti, iniziative comunali per l’assistenza ai profughi della Libia, riparati a Modica. Un complemento al mio libro “IL RITORNO” 1922/1947 – che descrive quegli anni duri e molto sofferti. Ti ringrazio, caro Luca, per il tuo apprezzamento e incoraggiamento.
Anche se nell’opera non si fa esplicito cenno, è intuibile che ne “IL RITORNO” l’autore Giorgio Vindigni propone un racconto autobiografico, descrivendo i primi anni della sua vita nel personaggio di Giorgio Vinci. E nel farlo bisogna accreditargli, come suol dirsi, una “memoria di ferro” se sa cimentarsi – a distanza di ben settanta anni – in descrizioni molto puntuali e dettagliate.
Lo scenario in cui si svolge il romanzo è quello di Modica ed il periodo quello degli anni venti-quaranta, in pieno fascismo e 2^ guerra mondiale.
La trama del romanzo parte da Giorgio Vinci (il nonno, originario di Modica), per poi concentrarsi principalmente sul personaggio del figlio Antonio e della moglie Margherita, del nipote Giorgio.
Nel 1926 Antonio, al fine di migliorare le proprie condizioni di vita, aderisce alla richiesta governativa di lavoratori volontari per l’Africa italiana e vi si reca con la famiglia, andando a lavorare a Tripoli. Qui nel 1937 nasce il suo quarto figlio, Giorgio.
Nel 1940 Antonio riporta la famiglia a Modica, intendendo porla al riparo dagli effetti nefasti della guerra; ed egli riparte per Tripoli sperando di ricongiungervi a breve tempo la famiglia alla fine di quella che doveva essere una guerra di tipo “lampo” come propagandava il regime.
Giorgio, dall’età di tre anni, resterà a Modica per ben sette anni, sino a quando – cessato il conflitto – la famigliola si riunisce al padre a Tripoli nel 1947.
Una trama in fondo semplice, ma saputa arricchire dall’autore inserendola nel contesto storico nazionale ed internazionale del periodo bellico e post con gran numero di citazioni certamente utili al lettore quale “ripasso” al suo bagaglio conoscitivo (anche se, in verità, la loro numerosità talvolta rischia di appesantire la lettura e distrarre dalle vicende dei personaggi). Vicende storiche su cui l’autore con coraggio non lesina l’espressione di propri giudizi di valore, in larga parte condivisibili dall’odierno lettore.
Altro pregio che le pagine del romanzo offrono è costituito dalla diffusa descrizione delle tradizioni modicane di quel tempo: arti e mestieri, vita domestica, feste religiose, usanze e costumi, cibi e bevande, ecc. Da questo punto di vista il romanzo è definibile d’interesse antropologico culturale, tramandando alla storia parti del vissuto generazionale di quel periodo.
Le pagine che maggiormente attraggono e toccano sono quelle che si soffermano sull’intreccio dei sentimenti di un padre lontano dalla propria famiglia, di una madre che – con le mille privazioni e paure che comporta una guerra – ha la responsabilità di portare avanti una famiglia e di un figlio, il piccolo Giorgio, che cresce pensando spesso al padre lontano (che ricorda solo dalle foto) sforzandosi di imitarlo secondo le descrizioni della mamma.
L’autore, nella parte “biografia”, informa il lettore di aver trascorso, per motivi di lavoro, sei anni in Francia, a Parigi, e altrettanti in Svizzera, tra Berna e Ginevra, ove si è dedicato anche alla ricerca di documentazione storica per la stesura del romanzo.
Prof. Piero Vernuccio
Il Prof. Vernuccio ha voluto descrivere una panoramica del contenuto del libro “IL RITORNO”, mettendo in rilievo l’accortezza e la precisione nel ricordo di tempi lontani con le loro tradizioni e usanze, nonché i sentimenti che si sprigionano dagli atteggiamenti e dalla sofferenza dei protagonisti. Ringrazio il Prof. Vernuccio e ne rinnovo l stima.
Nella mia ultima mail, le avevo detto che le avrei risposto domenica, dopo aver letto il suo libro e ciò perché conoscendo la mia “lagnusia” a dedicarmi alle letture, prevedevo di impiegare più tempo. Invece mi sino bastate due lunghe sedute notturne, per completare di leggerlo: non mi veniva di chiudere il libro e aspettavo di leggere la pagina successiva e così il tempo passava, senza accorgermene. E un motivo c’era!!!!! Io, senza voler essere saccente, forse, sono il solo o meglio, sarò, uno dei pochi lettori del suo “romanzo”, come lo chiama lei, (ma io lo chiamerei “DIARIO”) che avrà letto quelle pagine, sentendosi partecipe di ciò che leggeva. Mi sembrava di essere nei panni di Giorgio, anche se io all’epoca avevo il doppio della sua età! Quello che aveva vissuto lui, l’avevo sperimentato sulla mia pelle, perché anch’io avevo un padre che era andato in Africa, a Bengasi, per affermarsi, in quegli anni, come avevano fatto tanti Italiani. Anch’io leggendo tutti gli avvenimenti storici e bellici, che lei ha succintamente riportato, per collegare la storia dei Vinci, alla trama del suo libro, ho rivissuto quegli anni tristi, della “fuga” dall’Africa a bordo di una nave mercantile. Anch’io, ho rivissuto la mia vita da profugo nel ragusano, alle prese con la “carta annonaria” per comprare il pane. Anch’io per lunghi cinque anni, subito dopo essere rientrato in Sicilia, nel 1941, ho vissuto a Modica, per completare i miei studi, e quindi leggendo il suo scritto, rivedevo, nuovamente, nella mia mente, il triste periodo della guerra, i Tedeschi che passeggiavano nel Corso, i vari luoghi in cui Giorgio si muoveva: San Giovanni, San Giorgio, il Pizzo, il grande orologio che campeggia in alto sul Corso Umberto, il Municipio, in cui ho vissuto momenti di panico, la Surda, e poi…..il dialetto medicano, (“specciu miu”, mi diceva la mia padrona di casa, Minaccia Vindigni), le tante cose buone che si potevano mangiare, per chi li poteva comprare, le “scacce”, il “pamkamel”, con il quale prima di recarci a scuola, riempivamo il nostro piccolo stomaco affamato. Solo chi ha vissuto quanto lei ha sapientemente descritto, può assaporare la lettura del sul libro. Gli altri, i giovani che lo leggeranno, non avranno le stesse nostre sensazioni, anche se apprenderanno, oltre alle tristi vicende famigliari di Giorgio, le vicende storiche di cui avranno sentito, prima, parlare. Ed è per questo, che la ringrazio fraternamente! Per avermi fatto rivivere gli anni della mia fanciullezza e della mia gioventù, che, sono sempre dentro di noi e non si dimenticano mai.
Ogni tanto però, è bello rivederli, quegli anni!!!!, leggendo le cose scritte e/o vissute da altri.
Farle i miei complimenti per il suo libro è scontato, dopo quello che le ho scritto prima, ma ritengo che ripeterglielo sia doveroso!
Complimenti Giorgio.
Architetto Angelo Nicosia
Quando ho letto il tuo commento, caro Angelo, mi sono commosso per il solo fatto che mi son detto: ” Ho colpito nel segno” ; son riuscito a far rivivere la storia a coloro che l’ hanno vissuta. Ti ringrazio per aver accolto l’invito per la Presentazione del libro “IL RITORNO” alla Casa della Cultura di Modica, avventurandoti da solo in vettura da Palermo, dove hai esposto con commovente e drammatica descrizione i duri momenti che fummo costretti a vivere lontani dalle nostre case in Libia. Aggiungo soltanto un GRAZIE.
Leggendo ” il Ritorno” dove tu, Giorgio, descrivi cosi’ bene le situazioni che ti hanno visto protagonista, ancora bambino, di storie avvincenti e difficili sono rimasta coinvolta emotivamente . Ti ringrazio, inoltre, per aver raccontato in modo chiaro gli avvenimenti bellici che accompagnano la storia di questa famiglia cosi’ forte e determinata.
Mi ha arricchita dentro lasciandomi una dolce e piacevole sensazione Complimenti Giorgio!
Cara Mariella, ti ringrazio per avermi comunicato le tue impressioni e emozioni nel leggere quanto ho scritto nel libro di narrativa storica (1922/1947) “IL RITORNO”. Quando vengo premiato e mi viene chiesto (come d’uso anche ad altri autori) se il libro è autobiografico, rispondo che chiunque abbia attraversato un periodo della vita, in un momento storico particolare, nella sofferenza e nei rischi, che lo hanno temprato, e può comunicare abilmente ad altri tali avvenimenti, è in dovere di farlo, perché il passato storico serva da insegnamento alle future generazioni, onde altri errori non abbiano a ripetersi. La storia raccontata da chi l’ha vissuta è la vera storia, rispetto a quella dei libri di testo che enuncia date e nomi, perché entra nei particolari che coinvolgono gli individui che la subiscono. Ancora grazie e aspetto una recensione sul secondo libro e prosieguo del primo “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” (1948/1959) –
Caro Carmelo, ti ringrazio per il tuo commento. Sono contento per aver raggiunto il mio scopo: emozionarmi nel fare emozionare il lettore dei miei libri. Spero essi vengano diffusi, perché: ” DIFFONDERE LA CULTURA E’ COSA MERITEVOLE; ESSA NON HA CONFINI NE’ LIMITI DI SORTA. IMPADRONIRSENE GRATIFICA LO SPIRITO – Giorgio Vindigni”
“L’adolescenza è l’età più bella nel cammino della vita……come vedi sono all’inizio del secondo libro “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” (1948/1959) – Bellissimo…….mi ricorda l’inizio della mia vita lavorativa in una Farmacia di Noto, che mi ha aiutato a crescere amando il prossimo sofferente ed in difficoltà. Grazie per avermi aiutato con il tuo libro bellissimo a rivivere le sensazioni di quegli anni. A presto….grande Giorgio.
Grazie Carmelo, sono contento di aver raggiunto lo scopo del ricordo in coloro che hanno vissuto quegli anni. La cosa mi commuove. Questo libro ha ricevuto in un anno sette Premi letterari. Definito “Un libro meraviglioso unico nel suo genere”. Devi leggere anche il precedente in ordine di tempo “IL RITORNO” 1922/1947 – Tredici Premi letterari e sei Titoli accademici – Definito “La storia contemporanea raccontata da chi l’ha vissuta” – Lo puoi ordinare, come l’altro, anche in internet; InMondadori – LaFeltinelli – IBIS – Amazon –
Da Arturo Pellegrino – Tripoli – Catania – 31 dicembre 2013
Sento il dover scrivere due righe, forse più, su di un libro scritto da un caro amico tripolino come me, Giorgio Vindigni, “IL RITORNO”. Ci ho messo tanti mesi per farlo e non riesco a spiegare il motivo, comunque so che lui mi perdonerà. Beh so che le recensioni di persone autorevli non gli sono mancate, letterati e professoroni, con parole talvolta da me quasi sconosciute, ma so che lui aspettava da tempo queste mie righe. Ho dovuto leggerlo due volte, eppure è scritto in modo semplice, scorrevole per niente complicato come certi libri che per capirli necessita avere a fianco un dizionario, meglio un professore di letteratura che ne spieghi il contenuto. Ho dovuto leggerlo due volte per colpa mia, perchè come tanti Italiani di Libia, quando leggiamo qualcosa scritto da uno di noi cerchiamo la descrizione dei posti dove siamo nati, dove siamo vissuti, della nostra gente, delle nostre storie. Siamo affamati di Libia devo usare questa parola, affamati, sperando di farmi capire anche dai non Profughi di Libia. La prima volta che ho letto “IL RITORNO” sono rimasto deluso, la Libia che cercavo era solo menzionata, aleggiava tra le righe, quasi accennata. Ci ho pensato un pò e ho concluso che in un libro scritto da un tripolino sicuramente avrei dovuto trovare qualcosa che mi riguardava. Ho deciso di rileggerlo ponendomi come se fossi stato un non Italiano di Libia e ho indovinato, io c’ero fra quelle righe. Il mio amico Giorgio riesce a spiegare, in modo estremamente puntiglioso, chi erano gli Italiani che lasciavano la propria terra natia per andare in un posto sconosciuto: la quarta sponda. Ma sponda di chi? Fra noi c’era gente che il mare non l’aveva mai visto, immaginate che gli fregava della quarta sponda! Noi sappiamo bene chi eravamo ma, Giorgio, lo spiega agli altri, alle generazioni future, lo registra nelle pagine della storia. Eravamo gente semplice, forte, piena di voglia di costruire, di vivere, di amare, di sognare, curiosa, senza alcun preconcetto razziale o religioso, che partiva insieme a tanti altri Italiani che era anche difficile da comprendere perchè parlavano una lingua quasi incomprensibile! Sentimenti che oggi si vuole cancellare, sembrano appartenenti all’uomo antico, antichissimo, l’uomo che non conosceva gli aerei, il computer e neppure immaginava internet e per finire: non aveva il cellulare! Sentimenti umani di gente semplice che voleva solo sognare e vivere dignitosamente e che ancora tutti gli Italiani hanno e necessita risvegliarli se vogliamo ricostruire un Paese migliore. Credo di poter dire che questo libro sembra un’autobiografia, quasi maniacale, incredibile quanto amore ci può essere in chi riesce a ricordare dopo cinquant’anni l’acquasantiera, il sigaro, la scabbia, i capelli lunghi, la fontanella, le scale e la morte di una singola persona alla fine della peggiore guerra che l’umanità abbia mai conosciuto. Ci sono anche cenni storici, la guerra, l’attentato a Togliatti, si tratta proprio di autobiografia però, non riguarda una sola persona, strano per un’autobiografia, riguarda decina di migliaia di uomini e donne e bambini che si sono ritrovati in una terra sconosciuta, dove si dovevano costruire case, strade, templi, cimiteri, bar, sale da ballo e poi giardini, uliveti, vigneti, grano, mais, mandorleti, boschi, storia e civiltà. Lo abbiamo fatto e ne siamo orgogliosi; eravamo gente semplice, la gente che viene descritta in questo libro, “IL RITORNO” . Grazie Giorgio
Arturo mi hai reso felice per il tuo commento. Ti consiglio di leggere il seguito in ordine di tempo “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” 1948/1959 – Definito “Un libro meraviglioso unico nel suo genere” – Per saperne di più vai su http://www.ernandes.net/vindigni – clicca sulla seconda foto del libro e troveraai parecchi documentari LUCE originali sulla conquista della Libia ed altro inerente. Un abbraccio, Giorgio
Carissimo, è stato un grande piacere incontrarti alla premiazione. Ti auguro ogni bene, che tu possa sempre continuare ad essere attivo ed ispirato.Sei la testimonianza vivente della storia dei nostri tempi, fa veramente tesoro della tua esperienza di vita per trasmettere valori, idee, conoscenze sul nostro essere umano e su come vivere ed operare, dando il meglio di sè.
Auguri, auguri. Loreta Nunziata
Cara Nunziata, è una grande soddisfazione conoscere persone che sappiano apprezzare il lavoro svolto con tanto impegno e dedizione, per tramandare agli altri quanto è accaduto durante gli anni precedenti il momento in cui viviamo. Il domani e i giorni avvenire non sono ancora storia, sono solo un’incognita. Scopo dei miei libri è quello di trasmettere esperienze, orrori, errori e soddisfazioni che la vita riserva, dai quali possano trarre insegnamento. Ai più anziani il ricordo del loro passato; qualcuno, dopo aver letto il libro “IL RITORNO” (1922/1947) – pluripremiato -, mi ha ringraziato commosso.
Il secondo volume della trilogia, “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” (1948/1959) – edito quest’anno
e già sei volte premiato – continua a narrare la storia successiva, interessante, avventurosa, commovente. Il terso volume, in lavorazione, chiuderà con gli anni ’70.
I volumi sono editi dalla HELICON di Arezzo.
Ancora grazie,
Giorgio Vindigni
Da Prof. J. Ovando Salemi – Santa Fè (Argentina)
Giorgio, Magnifico il tuo libro, dirò appassionante, fa due notti che ho cominciato a leggerlo. E’ veramente una narrativa imponente.
Caro Ovando, sono felice del tuo commento, credo che ti riferisci al volume “IL RITORNO” – 1922/1947 – (18 Premi letterarui e Titoli accademici). Mi dirai se ti ha colpito altrettanto “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE”- 1948/1959 – (Due Premi da inedito; da edito il Premio Internazionale PEGASUS – Città di Cattolica che ritirerò il 20 aprile 2013 – “PREMIO SPECIALE ASSOC. CULTURALE I.P.L.A.C.”
Spero che voglia diffonderlo in Argentina, come argomentato, per portare agli Italiani “Un pezzo di storia italiana”.
Grazie e a presto
Giorgio Vindigni
Caro Giorgio, anche questo libro “Aspirazioni di un adolescente” e’ molto molto bello, scorrevole, per la lettura.
Pur essendo autobiografico i fatti descritti sembrano scritti da persona estranea… ma in realta’ non e’ cosi!!! Bella, prerogativa…
Tre punti hanno colpito la mia attenzione ed a tratti anche commosso:
L’incidente stradale a Tripoli Durante l’occupazione inglese un camion militare ti travolse trascinandoti per diversi metri, colpendoti ad una gamba con sofferenze atroci e mesi d’ospedale, rischiando di perdere l’arto. Considerando la chirurgia di piu’ di sessanta anni fa’ la guarigione e’ proprio un vero miracolo.
La convinzione a Napoli per indossare l’abito talare, con la promessa di diventare un salesiano di Don Bosco, facendo voto di poverta’ e castita’ a quindici anni, non ancora maturo per decisioni di questo genere!!! Poi qualcuno ti ha fatto capire e desistere!!!
La continuazione dei tuoi studi a Tripoli, uscito dal Don Bosco, indirizzandoti pero’ su materie piu’ tecniche, fu’ dura ma alla fine con ottimi risultati!!! Con l’intenzione, poi, di proseguire e conseguire un laurea in medicina…
Le aspirazioni di un giovane sono tante, giustamemte… poi pero’,la vita, per varie motivazioni, sceglie la tua strada!!! come hai fatto tu seguendo le orme e senza volerlo le “aspirazioni” di tuo papa’ Antonio, diventando un bancario
Cari Saluti
Camerino Giuseppe
Caro Giuseppe, ti ringrazio per le belle espressioni che mi hai rivolto dopo aver letto “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE”. Non noto cenni sugli avvenimenti storici che hanno coinvolto la vita del Protagonista, dall’occupazione inglese in Libia (causa dell’incidente), i fatti del 1948 (guerra in Israele con conseguenze in Libia), 1956 eventi del Canale di Suez con ripercussioni nel Nord-Africa in cui il Protagonista stava per essre coinvolto… Storia dell’Emigrazione… eventi politici (CECA – EURATOM), luoghi turistici visitati… Naturalmente non potevi far cenno su tutti gli avvenimenti storici, ma trattandosi di “narrativa storica”, immagino che qualche cenno abbia attirato la tua attenzione. Un caro ringraziamento.
Giorgio Vindigni
“IL RITORNO” un libro che pian piano ti porta ai racconti dei nostri nonni, dei nostri genitori….parole che tornano alla mente….parole dei nostri ricordi….molte volte emozioni fortissime e lacrime per il tempo che fu…. Bravo!!!!! Ciaoooooooo…Un libro prezioso che conserverò con gelosia.
Cara Rossana, il tuo commento mi commuove e nello stesso mi esorta a continuare nel narrare la storia contemporanea che si intreccia con il vissuto. Il segreto sta proprio nel descrivere, nei particolari, gli avvenimenti vissuti per tramandarli ai posteri. Attraverso la loro lettura Essi rivivono il passato e ne traggono insegnamento per il futuro, per non ricadere negli errori e scegliere le emozioni più belle.
Caro Giorgio,leggendo il tuo libro,con i ricordi,sono ritornato indietro di una cinquantina d’anni.
Quando avevo dieci anni ,mia mamma,mi raccontava di suo nonno,che parti’ da Siracusa per la Libia e poi successivamente fu’ assegnatario di una “concessione”di una quarantina di etteri,che trasformo’, in un rigoglioso giardino.
Poi ancora..il nonno di mia moglie di nome” Giorgio”,che partito da “Modica”,arrivo’in Libia;grazie agli Inglesi,perche’ imbarcato sulla Royal Navy,come musicista;e padre Umile amico della famiglia di mia moglie.
Un libro bellissimo,di lettura scorrevole,che mi ha emozionato per i ricordi!!!!
Un piccolissimo “neo”,Giorgio;se mi permetti,due parole in piu’ su i nostri soldati,nella battaglia di
EL ALAMEIN ,che si sono arresi, pero’ dopo giorni di duri combattimenti (rapporto 1 a 6)sia d’armi che uomini ;con orgoglio ed onore (riconosciuto anche dagl’Inglesi);per commemorare quei momenti e’ stato costruito un Sacrario.
Per il resto ,tutto magnifico….complimenti Giorgio!!!
Un abbraccio e saluti
Giuseppe Camerino
Sono contento che il libro ti sia piaciuto e ti ha fatto ricordare il trascorso. Per quanto concerne i nostri soldati periti nel deserto e particolarmente nella battaglia finale di El-Alamein, troverai una esauriente descrizione nel secondo libro “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” che uscirà prossimamente. Mentre “IL RITORNO” tratta dal 1922 al 1947, il secondo libro riporta gli avvenimenti dal 1949 al 1959, accaduti nell’area mediterranea, in cui si muove il protagonista e fanno da cornice alla sua vita.
Per un Autore è importante sapere di aver riscontrato la soddisfazione del lettore nell’apprendere o nel ricordare avvenimenti che hanno fatto la storia. Ancora grazie per i tuoi apprezzamenti. Giorgio Vindigni
complimenti: il libro si legge tutto di un fiato (si può così dire?) scritto molto bene, chiaro ed esplicito nell’esposizione dei momenti dei luoghi e dei personaggi specialmente sulle truppe di occupazioni e sui bombardamenti. Che mai più tornino quei momenti. A quando il seguito? ciao. Agostino
Caro Agostino, ti ringrazio per il tuo commento. Scopo del libro è proprio quello di ricordare quanto molti abbiamo vissuto; è storia che anche gli altri debbono conoscere per evitare che ciò riaccada, come tu stesso auspichi.
Il seguito lo troverai sul secondo della triade “ASPIRAZIONI DI UN ADOLESCENTE” che uscirà a breve. Un abbraccio, Giorgio
Ciao Giorgio, ho finito di leggere il tuo ROMANZO di vita vissuta, per la seconfa volta perchè la prima letta, è stata a singhiozzi, visto che nel mezzo mi era capitato l’incidente d’auto.
Mi è piaciuto e devo dire che attraverso il tuo racconto ho rivisto tantissime analogie di vita vissuta e di vita raccontatami dai miei. Anche la disavvenrura di perdere una sorella “per me l’unica venuta al mondo in quanto siamo 6 e tutti maschi” è stato attraverso il tuo racconto, un ritorno di memoria. I giochi, i dolci pasquali, la casa degli spiriti, le lettere di Assunta e della Mamma al papà Antonio Vinci, la sofferenza per il distacco dai propri cari, in un certo senso, riscoprirli attraverso la tua storia e stato per me un fare pace con un pezzo della mia vita che il destino, per le varie e diverse vicissitudini subite ha riservato a noi che abbiamo lasciato la Libya. Quando un libro come il tuo “il ritorno”, arriva al cuore di chi lo legge, diventa quasi terapeutico.
Grazie
Caro Duilio, il tuo commento su “IL RITORNO” mi è piaciuto e, in un certo qual senso, mi conforta il fatto che, per coloro che non hanno vissuto certi momenti, ma li hanno sentiti raccontare dai genitori, quanto si legge è una conferma a quanto ascoltato; è vera storia. Sono contento di aver toccato anche il tuo cuore. La storia vera vissuta è quella che forma la storia di domani, perchè da essa si possono estrapolare gli avvenimenti che formano la storia futura. Non ho il piavcere di conoscerti personalmente, ma è come se ti conoscessi già. Grazie, amico mio.
Mi sono emozionato nel leggere il Suo commento. La ringrazio. Mi scriva sulla mia E-mail e La ricontatterò per darLe maggiori ragguagli. Cordialmente, Giorgio Vindigni
Caro Giorgio,
nel suo incipit ho letto uno spaccato della storia italiana, che ovviamente conosco, ma che, letto seguendo la storia di una famiglia assume il carattere di saga , non di saggio e coinvolge in modo particolare.
Oso pensare si tratti di una vicenda autobiografica. La canzone “Tripoli bel suol d’amore” , mi ha riportato all’infanzia, al mio nonno materno, che la sera ci voleva riuniti attorno al tavolo, per narrarci la guerra che lo aveva visto coinvolto…
Oggi so quanto lo tradivamo addormentandoci o ascoltandolo sbuffando.
La guerra per coloro che l’hanno vissuta è rimasta un immenso personale dolore. Il verbo ‘capire’ purtroppo non appartiene agli esseri umani. Si capiscono le storie soltanto quando si è chiamati a viverle.
Lei rende il racconto vivo e pulsante, romanzandolo. Forse l’unico modo per condividere e far partecipare è
narrare dando ai testi carattere di saghe.
La ringrazio molto a nome della mia e delle generazioni ancora più distanti.
Occorre il rispetto della memoria… di tutta la memoria, per affrontare il presente ed essere pronti al futuro.
Mi permetta di abbracciarla! Maria