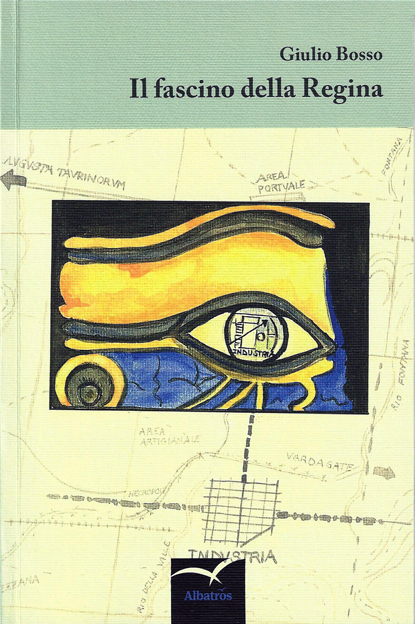
Gli scavi
La mano piena di polvere passava ripetutamente sulla fronte madida di sudore: i lunghi capelli biondi, incollati al viso, fuoriuscivano appena dall’ampio fazzoletto bianco che si era legato dietro alla testa per proteggersi dal sole implacabile di quel pomeriggio di fine giugno.
Era solo, nessuno quel giorno si era recato al campo di lavoro, perché i quasi quaranta gradi all’ombra che il termometro dell’auto segnava, già dalla tarda mattinata, avevano scoraggiato anche i più motivati ricercatori del gruppo; e sicuramente gli stimoli negli ultimi giorni si erano già naturalmente affievoliti, perché gli scavi andavano a rilento e, di conseguenza, anche i ritrovamenti erano rarissimi e poco significativi: scarsi frammenti ceramici, cocci di antiche lucerne votive, null’altro.
L’acqua nella bottiglietta di plastica aveva una temperatura quasi vicina all’ebollizione, ma doveva accontentarsi di quella, perché nelle vicinanze non c’erano bar, non c’erano chioschi, neanche fontanelle: il muro di pietre e mattoni che aveva alle spalle non era abbastanza alto da concedergli il privilegio di un’ombra ristoratrice.
Niente.
Nulla.
Solo ed esclusivamente raggi di sole quasi perpendicolari sulla sua testa.
“Chi me l’ha fatto fare” pensava tra sé Davide.
Ma in realtà provava una certa soddisfazione a essere l’unico superstite del gruppo di ricercatori che continuava alacremente il lavoro, nonostante le avverse condizioni climatiche. Era un modo come un altro per distinguersi dai compagni, per primeggiare, per dimostrare di essere il migliore: e, che dire, per lui essere il primo era un po’ l’obiettivo della sua vita.
Stavano scavando, su incarico della Soprintendenza ai Beni Archeologici, nei pressi dei resti di un edificio semicircolare, da tempo identificato come l’ambulacro per cerimonie sacre di un antico tempio romano. Negli anni passati, nel corso di svariate campagne di scavo, in quell’area erano stati rivenuti molti bronzetti votivi raffiguranti tori e una serie di piccole statue, non più lunghe di cinque – sei centimetri, le cui fattezze erano riconducibili alla dea egizia Iside.
Eh sì, poteva sembrare strano, ma in realtà, proprio in mezzo alla pianura piemontese, non lontano dal luogo in cui il Po riceve le acque fredde della Dora Baltea, esisteva un’antica città romana, Industria, i cui abitanti, sulla base delle scoperte effettuate, avevano edificato un tempio dedicato a Iside e uno a Serapide, i cui culti, provenienti dall’antico Egitto, si erano diffusi capillarmente un po’ in tutto l’Impero Romano, ma principalmente in Italia.
Il compito di Davide, viste le sue approfondite conoscenze di archeologia egizia, era quello di individuare tra i sedimenti del sito anche il più piccolo dettaglio, oggetto o particolare, che mettesse in luce le motivazioni per cui proprio a Industria il culto per Iside e Serapide si fosse diffuso in modo così partecipato fra la popolazione romana, se si fosse radicato presso tutte le classi sociali e le modalità che ne avessero portato alla netta interruzione verso il quarto, quinto secolo dopo Cristo.
La piccola cazzuola romboidale si conficcava con decisione, ma anche con esperta cautela, nel terreno sabbioso e limoso all’interno di quello che sicuramente era stato il Serapeion, il tempio dedicato a Serapide: i sedimenti parevano del tutto sterili, non emergeva nulla di interessante se non pochi frammenti ceramici riconducibili forse ai resti di qualche vaso votivo; come si era soliti fare nel corso delle campagne di scavo, il gruppo di ricercatori aveva suddiviso l’area di indagine in una serie di quadrati delimitati da corde; tutto il sistema di coordinate era riprodotto in scala su una planimetria cartacea, sulla quale Davide riportava, con attenzione e precisione, il punto esatto di ogni singolo ritrovamento.
Un sorso d’acqua, calda, e via a dar vita a quel terreno immobile da almeno 1600 anni; uno sguardo al cielo, sereno, ma non azzurro, velato da quella cappa di calda umidità che solitamente arriva a luglio, quasi a voler cercare un po’ di ossigeno o un refolo d’aria meno opprimente che però non c’era e non si riusciva neppure a immaginare.
Davide si guardava attorno ed era veramente solo: anche sulla vicina strada che conduceva al paese, che certamente ricalcava parte dell’antica viabilità romana, a quell’ora e con quel caldo, a fianco delle strutture militari abbandonate da anni, nessuno osava transitare; non si sentiva il vociare dei bambini e dei ragazzi del non lontano parco giochi e neppure il rumore scoppiettante dei trattori degli agricoltori; il mais era già alto, ma non necessitava di trattamenti in quel periodo, se non una metodica irrigazione; il grano stava giungendo a maturazione, ma le grandi, potenti mietitrebbia erano ancora inoperose.
Riprese il lavoro, fiacco, monotono, quasi noioso: il tempo sembrava trascorrere molto lentamente, in quel silenzio assordante che lo circondava. Il bianco fazzoletto sulla sua testa, portato come una bandana, non ce la faceva più a contenere il sudore.
“Se almeno trovassi qualcosa d’interessante…”.
Il nulla.
Niente.
Solo sole.
Solo caldo.
Solo afa.
E un terreno sabbioso sterile.
Dopo un’altra mezz’ora decise di fare una nuova pausa.
Si alzò e andò a sedersi all’ombra del muro di quello che era stato identificato come il tempio di Iside: l’altezza dei ruderi superiore ai due metri creava una stretta ombra, una piccola oasi personale all’interno della quale era possibile ristorarsi.
Davide appoggiò la testa al muro in mattoni regolari, nobile costruzione del passato, e chiuse gli occhi; lì, un timido sbuffo d’aria sembrava percepibile e pareva voler asciugare il sudore che grondava da ogni suo poro.
Le mani strinsero un po’ di sabbia e terra, terra sacra agli antichi romani, terra arida e fonte di delusione ora, per Davide.
Poi, inatteso, arrivò.
Le nubi si erano addensate con una rapidità inusuale dietro alle colline, da sud. Davide non le poteva vedere, perché era voltato esattamente verso le montagne, verso il fiume non lontano.
Erano cumulonembi scuri, compatti, che sembravano ribollire in un cielo che da lattiginoso in breve era diventato scuro e gravido di pioggia: il sole era presto scomparso, un’improvvisa folata, violenta, di vento, aveva ridestato Davide dal torpore in cui il caldo e la stanchezza lo avevano precipitato.
Si voltò e rimase basito.
Le chiome dei pioppi cipressini e dei tigli che cingevano l’area archeologica erano già squassate da forti e ripetute raffiche di vento e si inclinavano paurosamente verso nord.
Il cielo aveva preso vita, vapori minacciosi, illuminati dagli accecanti bagliori dei fulmini, lasciavano presagire a un evento temporalesco di notevole entità. Il lontano, sordo, sommesso, brontolio dei tuoni lasciò quasi subito il posto a colpi secchi, ravvicinati, assordanti.
Mulinelli di polvere cominciarono a sollevarsi; gli occhi di Davide ne furono accecati, una finissima sabbia tra le palpebre e l’iride gli provocava un’intensa lacrimazione.
Raccolse in fretta la mappa del sito su cui stava annotando gli scarsi ritrovamenti e, quasi alla cieca, controvento, raggiunse la piccola tettoia che si trovava a pochi passi dallo scavo, lungo la ferrovia: era una costruzione di una ventina di metri quadrati, con la struttura portante in legno e la copertura con onduline in plastica, aperta su tutti e quattro i lati; sotto vi era un tavolaccio in legno, di quelli che si trovano nelle aree picnic, e un paio di panche: i ricercatori lo usavano come punto di appoggio per decidere gli interventi al mattino e per trarre le loro conclusioni e per confrontare i rispettivi progressi al termine di ogni giornata.
Cominciarono a cadere gocce grandi e pesanti, che a contatto col suolo secco e riarso sollevavano piccoli sbuffi di polvere, poi la pioggia si fece violenta, intensa, disordinata per via del vento che la trasportava ovunque.
***
Il fascino della Regina
di Giulio Bosso
2013, 188 p., brossura
Gruppo Albatros Il Filo
Ordina questo libro
Il commento di NICLA MORLETTI
Un gruppo di ricercatori lavora alacremente durante una campagna di scavi archeologici nella pianura piemontese. Si viene a scoprire che lì esisteva una città romana, Industria, i cui abitanti avevano edificato un tempio dedicato a Iside e uno a Serapide, divinità adorate nell’antico Egitto il cui culto si era diffuso un po’ ovunque nell’impero romano. L’incipit della storia trae origine dagli scavi con Davide, protagonista del romanzo, sul campo di lavoro, la fronte madida di sudore, sotto il sole implacabile di fine giugno con quaranta gradi all’ombra. Il ragazzo prova quasi una certa soddisfazione, nonostante le avverse condizioni climatiche, ad essere l’unico superstite del gruppo di ricercatori. Si tratta di un sentimento nuovo, quasi euforizzante che lo fa sentire più forte dei compagni, uno stimolo ad essere migliore, forse una sfida nei confronti della vita stessa. La campagna di scavo, proprio in quel tratto in cui il Po riceve le acque fredde della Dora Baltea, luogo in cui erano stati rinvenuti bronzetti votivi e statue riconducibili a Iside, la grande Dea, Regina d’Egitto, è un fatto entusiasmante, elettrizzante. E qui per un secondo tutto sembra fermarsi, forse anche l’autore stesso, con abile maestria, crea un attimo di suspense, prima dello scatenarsi della tempesta.
Giulio Bosso, con una scrittura lineare, chiara, precisa, ci trascina in un vortice di emozioni attraverso un viaggio misterioso e affascinante nell’antico Egitto coinvolgendo il lettore in una trama magistralmente costruita e amalgamata con simboli e parole magiche. Seguono eventi straordinari e inquietanti a sconvolgere quel piccolo paese del Piemonte nei pressi degli scavi archeologici: la morte violenta di alcune persone e strani simboli sui cadaveri. Il romanzo si tinge così di noir, dando ancor di più quel tocco di mistero e suspense alle pagine che lo rendono interessantissimo e coinvolgente. “I più grandi segreti sono quelli spalancati davanti a noi” scriveva Don De Lillo. E agli occhi del lettore si aprirà, improvviso, un mondo nuovo, con nuovi orizzonti da esplorare ed emozioni da provare, in una storia infinitamente ben delineata e narrata che incuriosisce e lascia con il fiato sospeso. Scriveva Cornelio Fabro: “Chi sceglie il finito, segue il destino del finito e il destino del finito è di trascinare il finito nel finito, infinitamente.” È il caso del Fascino della Regina che l’autore dedica a Isabella, Regina della sua vita. Bellissimo.


